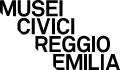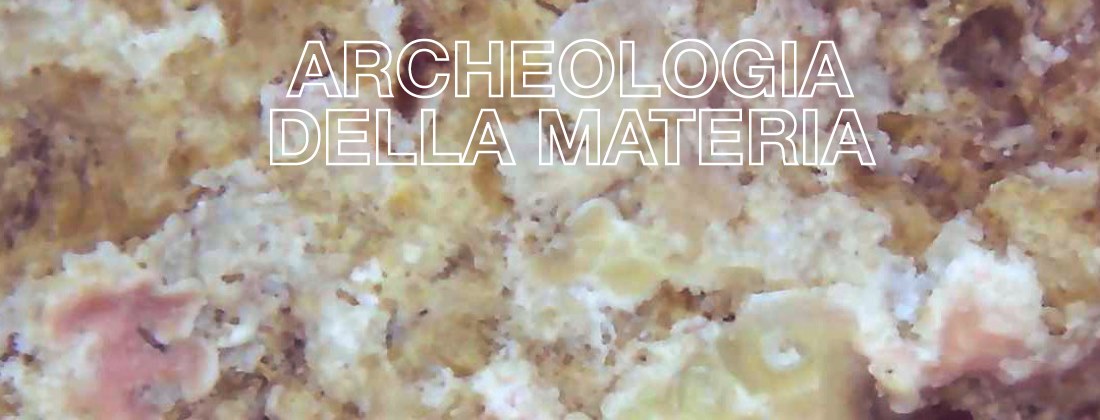NEUTRO
14.03.2021 – 02.05.2021
Quando ho visto per la prima volta la mostra di Caterina Morigi, passando davanti a Neutro e buttando un occhio per vedere se era stata allestita una nuova esposizione, non ho colto subito la relazione tra originali e riproduzioni; mi sembrava un’operazione di installazione paratattica di oggetti la cui “banalità” si recuperava nell’estetica della musealizzazione; la mia attenzione si è concentrata quindi sulla volontà di trasformare un display in una installazione, ovvero la pura gratificazione visiva e noetica (una astrazione non solo di forme ma anche di concetti, una spoliazione razionale di significato) generata nel momento in cui la trasmissione di saperi non è necessaria.
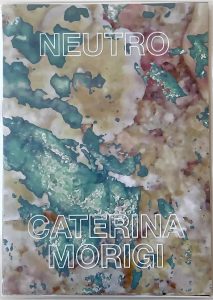
“Archeologia della materia” sarebbe dunque la suggestione di una forma che abbaglia per l’assenza di specifiche didascaliche, una citazione colta e raffinata che soddisfa lo sguardo senza la pesantezza, la responsabilità, del dover sapere. Una soluzione formale analoga è quella di Damien Hirst quando vetrinizza la medicalizzazione (Pharmacy); ma lui ci mette di fronte ad una estetica fredda e tassonomica che risulta, in quanto contenente elementi di disturbo e di sofferenza, un paradosso morale ed esistenziale. Qui manca l’elemento antropico, esiste solo la materia nel suo essere tale e quale, brutale e perfetta.
Poi ho scoperto la relazione tra originale e riproduzione e allora tutto si è piacevolmente intorbidito. In primo luogo l’elemento antropico c’è eccome; una riproduzione raffinata, in materiale nobile, realizzato da artigiani sapienti e nel solco della grande tradizione artistica. Alla luce di questa verità complessa, Archeologia della materia cosa significa? Che c’è un discorso relativo all’origine (arché) della materia, un calembour che mischia la disciplina con l’etimologia? O che la materia prodotta nei processi naturali e quella nelle pratiche artistiche si separano in quel punto originario, nel quale possono competere in maniera così perfetta da poter generare la stessa cosa? Credo che la risposta sia affermativa in entrambi i casi, e che l’opera induca a riflettere su queste categorie, del “fare” e del “farsi” della materia, dei suoi processi generativi che, in modo raffinato, finiscono per divenire elementi concettuali.
A questo punto il secondo elemento che mi è balenato nell’approfondire questo lavoro, era naturalmente quello relativo alla copia. In tutte le sue declinazioni: la copia come categoria implicita nella musealizzazione, per cui un tempo, prima che dal punto di vista della fruizione culturale si ritenesse fondamentale l’autenticità materiale rispetto a quella – chiamiamola – narrativa (o ideologica), se un pezzo non conservato presso una istituzione museale era ritenuto necessario alla completezza del percorso, se ne esponeva un copia. Impossibile per me non ricordare che a poche centinaia di metri di distanza c’è Palazzo dei Musei e la collezione paletnologica di Gaetano Chierici, che con analoga ossessività esibisce materiali che spesso faticano a parlare da soli, e che in moti casi esibiscono copie e originali (non del medesimo oggetto, ma magari della medesima categoria) per offrire una più vasta completezza allo studioso.
La copia è di per sé processo; è ad esempio un passaggio fondamentale nei processi di apprendimento e di formazione, nelle pratiche di insegnamento molto prima della scoperta dei neuroni specchio. Si tratta di un elemento fondamentale nella costruzione dell’identità dell’arte nel pensiero occidentale, si pensi ovviamente a Platone. La copia fa anche parte dei processi di costruzione della propria identità personale, come lo è la sua controparte perturbante (l’ombra, il doppio). Per imparare a fare arte, bisogna innanzitutto copiare. Copiare dal vero, copiare gli antichi; copiare per appropriarsi dei saperi e delle tecniche, e per divenire originali (Winckelmann).
Nell’opera di Caterina Morigi copiare mi sembra essere l’atto originario che ci permette, con i mezzi (i processi) suoi propri, di ripartire laddove la natura stessa è partita, per arrivare al medesimo risultato.

Terzo elemento: se copio in qualche modo rappresento l’oggetto copiato, anche se lo riproduco in ogni sua sembianza. A livello sostanziale, la rappresentazione è la massima distanza dall’oggetto che rappresenta, la sua differenza assoluta. L’autenticità della rappresentazione dunque non è tanto da ricercare nella facies, nel suo aspetto, ma in ciò che enuncia. Questo vale anche nel momento in cui l’esposizione stessa è la rappresentazione di questa modalità di rappresentazione: la vetrina, illuminata dall’interno, inevitabilmente “quadrizza” la visione, ne fornisce per così dire lo “spazio di enunciazione” (Marin) all’interno del quale la relazione tra copia e originale produce il proprio significato. Come enuncia quest’opera? Cosa nella sua icasticità la rende accessibile? Come detto all’inizio, prima di sapere quanto fosse complessa questa proposta, avevo equivocato credendo che essa giocasse sulla liberazione dal sapere, recuperasse soltanto il piacere insito nella ripetizione del dato oggettivo e della sua relazione con la pratica del display. Cosa avrei dovuto vedere, cosa mi è sfuggito?

In questo caso, “Archeologia della materia” sarebbe un’opera che necessita, per così dire, di istruzioni. Come osservare un oggetto prezioso ma non comprenderne il codice; come, per l’appunto, osservare un oggetto proveniente dal passato remoto, o da un altro pianeta. In ciò l’archeologia non è solo un discorso sull’origine della materia, ma è anche una disciplina, reale o immaginaria, che può fare luce su questo mistero, risalire alla sua arché. Ma la rivelazione immediata di questo codice avrebbe tolto il gusto che ho provato nello scoprire, un passo alla volta, lentamente e dopo essermene interessato, i molti risvolti “opachi” di questa operazione, e che ha reso anche la fruizione un processo intrigante, una ricerca, e infine una (parziale, come è giusto che sia) scoperta.