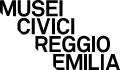IL PONTE
Il viaggio lungo questo tratto della Via Emilia inizia con il Ponte di Rubiera. Fu ricostruito dagli imperatori Valeriano e Gallieno dopo un incendio. Le monete esposte richiamano la targa onoraria che celebra questo evento. Sotto l’arco del ponte scorrono le acque del fiume Secchia e sul fondo si possono scorgere i reperti trasportati dalla forza della corrente. I personaggi rappresentati lungo le pareti si alternano a citazioni dalle fonti scritte, accompagnando il visitatore in un percorso che narra avvenimenti locali inseriti in una storia più ampia.