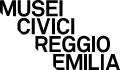3 – Gli oggetti-ricordo della guerra e della Resistenza | I souvenir del dolore
Se esiste una categoria alla quale si possono ascrivere i ricordi di guerra, è quella dei “souvenir del dolore”. Oggetti personali dei soldati, reperti archeologici e opere d’arte trafugati, cartoline commemorative di esecuzioni e linciaggi e persino i resti umani dei nemici uccisi hanno fatto coniare agli esperti la locuzione “Dire Souvenir Mania”, riferita ad una vera e propria “mania dei souvenir spaventosi” diffusasi negli Stati Uniti nel primo Novecento. Ovunque nel mondo vi sia stata una occupazione le forme di violenza e controllo nei confronti delle popolazioni sottomesse hanno generato la produzione di “souvenir del dolore”, simbolo fisico dei presupposti su cui si regge la supremazia coloniale.
Tali ricordi possono essere definiti anche “anti-souvenir”, in quanto, se la funzione dell’oggetto-ricordo è generalmente di creare continuità narrativa con il passato, questi invece spesso non sono celebrazioni nostalgiche del tempo che fu, ma esprimono il desiderio di una presa di distanza dalla storia stessa.
Tuttavia, tali “anti-souvenir” richiamano la complessità della narrazione che soggiace a tutti i souvenir in genere: come gli oggetti raccolti nelle Wunderkammern illuministiche che rappresentano la sete di conoscenza, ma sono anche testimonianza di saccheggi e conquiste; oppure come i ricordi di viaggio esotici esposti da istituzioni pubbliche, quali i musei, che intendono evocare l’essenza di popoli antichi e distanti, ma che spesso hanno ridotto culture remote a stereotipi semplicistici e umilianti.
Approfondimenti:
Tra memoria personale e propaganda coloniale
Tornare da un conflitto bellico non significa solo lasciarsi alle spalle il fronte, ma anche portare con sé testimonianze materiali che condensano l’esperienza vissuta: armi, fotografie e altri oggetti che si trasformano in ricordi di guerra, elementi tangibili che racchiudono memorie personali, ma che in molti casi costituiscono autentici trofei.
La guerra italo-etiope del 1935-1941 costituisce un episodio centrale nella costruzione dei ricordi di guerra dei soldati italiani che parteciparono a quella campagna coloniale. Il conflitto, promosso dal regime fascista come rivincita simbolica dopo la sconfitta di Adua nel 1896 e permeato dallo spirito imperialista che aveva come antecedente la grandezza dell’antica Roma, dispiegò un apparato propagandistico senza precedenti, che lo trasformò in un evento mediatico di massa. Un mese prima dell’inizio della guerra, l’Istituto LUCE creò il cosiddetto Reparto LUCE Africa Orientale e trasferì la sua sede ad Asmara (Eritrea), dove venivano organizzate e realizzate in modo centralizzato le produzioni fotografiche e cinematografiche. A questo proposito, il ruolo svolto dallo Stato e dallo stesso Istituto LUCE influenzò direttamente l’immaginario visivo dei combattenti attraverso la diffusione di serie fotografiche ufficiali con un chiaro intento informativo e propagandistico, che contribuirono a diffondere una serie di stereotipi, molti dei quali erano già stati modellati non solo dalla propaganda fascista prebellica, ma anche dalla missione cattolica durante il XIX e l’inizio del XX secolo.
Il facile accesso a queste fotografie, provenienti da contesti produttivi propagandistici o commerciali –la maggior parte in formato cartolina– così come a quelle scattate dagli stessi soldati o dai loro compagni, permise loro di creare una collezione di ricordi e un archivio della memoria che segnò la conclusione dell’avventura in Africa orientale, dettata dalla necessità di raccontare la propria esperienza. Queste collezioni personali di immagini ci offrono una testimonianza vivida delle emozioni, delle aspirazioni e dei miti che hanno segnato quella generazione, profondamente influenzata dalla retorica patriottica dell’ideologia fascista e dalla sete di avventura e di dominio su un territorio considerato “esotico”.
Uno di quelle migliaia di soldati che parteciparono alla seconda guerra italo-etiope e che tornarono a casa con un bagaglio carico di ricordi fu Ferdinando Rossi, il cui lascito fu donato alcuni anni fa alle collezioni etnografiche dei Musei Civici di Reggio Emilia.
*
Ferdinando Rossi e i suoi ricordi di guerra
La collezione Rossi, oltre a includere alcuni oggetti —come un cappello, due fruste, un bossolo di mortaio, due punte di lancia in ferro e due carte geografiche, una delle strade italiane e un’altra dell’Africa Orientale del Touring Club Italiano—, è composta principalmente da oltre un centinaio di immagini, tra fotografie e cartoline, che Rossi raccolse durante il suo soggiorno in Africa Orientale, alle quali si aggiungono anche quelle che inviò per posta a familiari e amici durante la campagna bellica. L’insieme di queste fotografie, così come quelle di altre collezioni private di soldati della campagna, offre una narrazione visiva che integra il racconto ufficiale. Oltre a incorporare quella serie di stereotipi ufficiali e commerciali nelle sue dinamiche di visualità personale, la collezione include sguardi più intimi: istantanee scattate da lui stesso o dai suoi compagni d’armi, che registrano scene di vita quotidiana e rapporti di cameratismo tra soldati, fino agli incontri con le popolazioni locali. Sono presenti anche immagini più crude, che riflettono il macabro rituale della guerra, come l’esibizione delle punizioni o delle umiliazioni corporee, al di là delle rappresentazioni propagandistiche.
La collezione fotografica e postale di Ferdinando Rossi può essere intesa come un complesso dispositivo di memoria visiva che, lungi dall’essere un semplice insieme di immagini sparse, funziona come un vero e proprio ricordo di guerra, accuratamente composto. Attraverso le sue diverse sezioni tematiche −dai monumenti, le scene militari e le questioni politiche, fino agli incontri con la popolazione locale, i tipi femminili o le scene di vita quotidiana− la collezione articola un racconto personale che, al tempo stesso, è profondamente attraversato dalle logiche visive e ideologiche del regime fascista e dall’immaginario coloniale dell’epoca.
Queste immagini rispondevano a molteplici funzioni. In primo luogo, come mezzo per appropriarsi simbolicamente di esperienze di alterità: catturando l’esotico, il diverso, l’estraneo, il soldato-colono affermava la propria posizione di potere in quanto osservatore e conquistatore. In secondo luogo, molte delle fotografie −in particolare le cartoline postali− avevano una chiara funzione comunicativa: trasmettere alla famiglia e ai propri cari un’immagine del territorio, delle sue genti e delle sue culture, secondo uno sguardo costruito dalla distanza coloniale. Alcune di esse, come quelle che rappresentano l’imperatore Hailé Selassié o i corpi dei “sottomessi”, funzionano inoltre come trofei di guerra, in cui il potere militare si traduce in immagini che consacrano la dominazione sul nemico.
Infine, la stessa selezione e conservazione di queste immagini in un archivio personale rivela il loro uso come strumento per raccontare l’esperienza individuale della guerra, costruendo una memoria soggettiva che mescola orgoglio, curiosità, violenza e nostalgia. In questo senso, la collezione Rossi non solo ci permette di comprendere meglio l’esperienza coloniale attraverso lo sguardo del soldato, ma ci invita anche ad analizzare come le immagini costruiscano e fissino il ricordo, lasciando tracce visive che prolungano la guerra oltre il fronte, inscrivendola nella sfera della vita privata e della storia personale.
José Javier Aliaga Cárceles
Universidad de Murcia
La Scuola di Arti e Mestieri di Tripoli fu fondata tra il 1879 e il 1880 e poi inaugurata nel 1898, durante il governo ottomano di Nàmuq Pascià. Nata per offrire un’educazione professionale a giovani arabi orfani e indigenti, formava artigiani in mestieri come falegnameria, meccanica, sartoria, oreficeria, calzoleria e tessitura. I prodotti dei laboratori contribuivano al sostegno economico dell’istituto, che divenne presto uno dei principali centri educativi della Tripolitania.
Con l’occupazione italiana del 1911, il sistema scolastico ottomano venne smantellato e la scuola subì profonde trasformazioni: dapprima chiusa e riconvertita a uso militare, riaprì nel 1912 come orfanotrofio, per poi ritrovare solo negli anni Venti un nuovo ruolo all’interno della politica coloniale. L’amministrazione italiana rilanciò l’artigianato libico, riconoscendo alla scuola un ruolo strategico nell’economia e nello sfruttamento coloniale.
Nel 1924 fu istituito l’Ufficio delle Arti Applicate Indigene, destinato a promuovere la produzione e il commercio dei manufatti locali. Quattro anni dopo, un nuovo statuto consolidò la doppia funzione assistenziale e formativa della scuola. Tuttavia, le riforme fasciste del 1928 limitarono fortemente l’accesso dei libici all’istruzione superiore, rendendo la Scuola di Arti e Mestieri l’unica possibilità di formazione avanzata per gli studenti locali.
I corsi di formazione – in falegnameria, oreficeria, meccanica e tessitura – miravano a creare una manodopera specializzata capace di produrre oggetti d’arte e d’artigianato di tradizione libica, ma fortemente riconfigurati secondo lo sguardo e il gusto della Madrepatria. Questi manufatti venivano esposti e venduti a Tripoli e in Italia come souvenir coloniali: tracce materiali di un “altrove esotico” che permettevano ai coloni di portare con sé un frammento dell’immaginario libico costruito dal potere coloniale. L’artigianato, da pratica identitaria, divenne così strumento di rappresentazione e consumo dell’alterità.
Nel 1938 la scuola assunse il nome di Scuola Musulmana di Mestieri e Arti Indigene, sancendo la separazione tra studenti italiani e arabo-libici. Parallelamente, i prodotti artigianali locali venivano sempre più sfruttati a fini economici e turistici: l’artigianato tradizionale libico divenne così parte della politica coloniale di “valorizzazione” delle arti e tradizioni artigianali locali, ma anche uno strumento di controllo sociale ed economico.
Oggi, la Scuola di Arti e Mestieri di Tripoli – trasformata in fondazione storica nel 2001 – è riconosciuta come parte del patrimonio culturale della Libia. La sua sede storica, nell’ex quartiere italiano, rimane una testimonianza di un passato in cui politiche educative, artigianato e propaganda si intrecciarono profondamente.
Rosa Anna Di Lella
Museo delle Civiltà, Roma
DIDASCALIE VETRINA 3
GLI OGGETTI-RICORDO DELLA GUERRA E DELLA RESISTENZA
IL RICORDO DI GUERRA
1
Sciabole con fodero
Africa, Sudan, 1879
Ex proprietà di Sulaymān Zubayr e poi di Romolo Gessi
Le due sciabole provengono dall’importante bottino che Romolo Gessi, militare ed esploratore, nel 1879, ottiene dopo aver guidato una campagna nell’Alto Nilo contro Sulaymān Zubayr, influente leader locale e mercante di schiavi. Documentate dal fotografo Richard Buchta, dopo essere entrate nelle collezioni del Museo Pigorini di Roma, sono trasferite nel 1902 al Museo Archeologico Nazionale di Parma e nel 1970 ai Musei Civici di Reggio Emilia
2
Album della Scuola di Arti e mestieri di Tripoli
Libia, anni Trenta del Novecento
Museo delle Civiltà, Roma
3
Cuscino in pelle
Libia, anni Trenta del Novecento
Museo delle Civiltà, Roma
4
Cappello
Africa Orientale Italiana (A.O.I.), 1936 ca.
Raccolta M. P. Rossi, Musei Civici di Reggio Emilia
Bossolo di mortaio
Africa Orientale Italiana (A.O.I.), 1936 ca.
Raccolta M. P. Rossi, Musei Civici di Reggio Emilia
Frustini
Africa Orientale Italiana (A.O.I.), 1936 ca.
Raccolta M. P. Rossi, Musei Civici di Reggio Emilia
Punte di lancia in ferro
Africa Orientale Italiana (A.O.I.), 1936 ca.
Raccolta M. P. Rossi, Musei Civici di Reggio Emilia
5
Bustina con immagini ricordo “Tipi, usi, costumi dell’A.O.I. 20 soggetti”
Africa Orientale Italiana (A.O.I.), 1936 ca.
Raccolta M. P. Rossi, Musei Civici di Reggio Emilia
6
Cartoline e fotografie (VIDEO)
Africa Orientale Italiana (A.O.I.), 1936 ca.
Raccolta M. P. Rossi, Musei Civici di Reggio Emilia