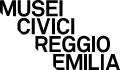5 – I souvenir personali e la memoria autobiografica
La questione dell’autenticità
Se all’inizio del XIX secolo i ricordi di viaggio sono spesso rappresentati da manufatti e oggetti locali creati da artigiani, circa un secolo dopo si diffondono la produzione in serie e una rete di produttori e distributori a livello globale. L’offerta di souvenir sempre più estesa e innovativa diventa strumento di marketing per l’indotto turistico: conseguentemente il fenomeno della contraffazione si ripresenta, nel solco di una tradizione risalente ai pellegrini medievali e ai partecipanti del Grand Tour, e in parallelo aumenta l’interesse per il concetto di autenticità.
I viaggiatori più attenti cercano souvenir radicati nelle tradizioni locali, poiché gli oggetti folkloristici tendono a sembrare autentici rispetto ai prodotti definiti “in serie”. L’idea di autenticità contemporanea, intrisa ancora nel XXI secolo di preconcetti esoticizzati, viene riconosciuta soltanto alle culture percepite tutt’ora come tradizionali. In questo rifuggire dalla modernità, divenuto espressione tipica della modernità stessa, accade che i turisti spesso non apprezzino gli autentici prodotti della cultura straniera, preferendo guardare alle altre culture attraverso una lente tradizionalista, che induce le popolazioni autoctone a presentarsi consapevolmente in una versione stereotipata di sé stesse, al fine di trarne profitto. Negli anni ’70 antropologi e sociologi hanno definito questo comportamento condizionato dalle aspettative “autenticità simulata”.
La casa come archivio familiare
La memoria autobiografica rinnova il passato tramite ricordi, oggetti, profumi, suoni ed emozioni che danno forma all’identità personale. Gli oggetti, in particolare i souvenir, sono agenti centrali nel processo di costruzione del sé, rappresentando una base solida da cui partire per narrare la propria storia. Raccogliere testimonianze della propria vita e conservarle è una metodologia di costruzione identitaria: oggetti significativi, cimeli che raccontano esperienze passate, variopinti “memento mori” che ricordano l’attimo che si è colto, accompagnano la strutturazione del sé e supportano uno stato di benessere identitario.
In questo processo la casa funge da archivio storico della famiglia, offrendo continuità e contesto per conservare tali frammenti. Tuttavia, souvenir e oggetti che hanno un ruolo centrale nel delineare la biografia e l’identità personali sono influenzati da dinamiche di consumo e standardizzazione globale: pertanto, comprendere questo dualismo diviene essenziale per una interpretazione, una lettura critica della memoria autobiografica e delle pratiche di conservazione della casa come archivio familiare.
Approfondimenti:
Souvenir vuol dire, originariamente, ricordo, e poi per estensione diventa un oggetto capace di rievocare il ricordo di un luogo o di un evento in cui si è stati presenti. In miniatura, il modellino di un campanile, una conchiglia, una foto sbiadita, avrebbero il potere di farci viaggiare indietro fino a quel momento perduto. Se raccontare – come ha scritto Carlo Ginzburg – «significa parlare qui e ora con un’autorità che deriva dall’essere stati (letteralmente o metaforicamente) là e allora», il souvenir conterrebbe quindi un racconto, che si sprigionerebbe da quel piccolo oggetto come il genio dalla lampada.
Così inteso, il souvenir è capace di evocare la nostalgia per qualcosa di perduto e irredimibile, che rivive in immagine: «Il ricordo di una certa immagine non è che il rimpianto di un certo istante», come scrive Proust. Ma la magia funziona solo per chi il viaggio l’ha fatto, o il racconto lo conosce. Il souvenir tuttavia sopravvive, staccato da quella storia e da quella memoria. Così, può finire col significare un vuoto di memoria, una nostalgia per qualcosa che non si è mai visto, per un viaggio che non si è mai fatto.
Il primo souvenir che ricordo di aver visto era un modellino di un grattacielo di New York in una palla di vetro con neve, inviato dai miei bisnonni emigrati in America ed esposto nella vetrina di un salotto in un paese del Sud Italia. M’incanta quel palazzo celeste, e mi appassionai a quelle sfere che includevano un mondo silenzioso in cui volevo entrare; cominciai a collezionarle. Molti anni dopo ho scoperto che all’inizio le palle di vetro con neve erano state inventate come strumenti per illuminare sale operatorie. A volte i fiocchi di neve erano fatti d’osso, gli oggetti ritratti per i primi turisti-pellegrini, erano chiese. Somigliava a un reliquiario medievale, in cui si esponeva un frammento della croce di Cristo o l’unghia di un martire. E il glicerolo all’interno, che rallentava la caduta della neve, era lo stesso liquido con cui si conservavano i corpi umani. All’improvviso quella palla magica non appariva più come la scintilla di un ricordo vivo, ma una tetra icona della vita estinta, quasi un reperto di storia naturale, di un mondo morto. Quella New York, del resto, non esiste più, e lo stesso deve dirsi di gran parte degli oggetti ritratti nei souvenir.
Questo senso funebre di scomparsa appare particolarmente appropriato considerando le foto etnografiche: quelle dell’Africa italiana, o quelle degli Indios Ona in questa collezione. Come altre popolazioni indigene della Terra del fuoco, gli Ona, o Selk’nam, furono sterminati dal colonialismo. Eppure il loro fantasma ha continuato a agitare la memoria, rimandando a un’esperienza aspra del territorio e alla capacità umana di sostenerne la fatica e l’incertezza, di cui quel popolo diede una potente espressione. Lo storico delle religioni Ernesto de Martino ricorda proprio i Selk’nam nel suo capolavoro Il mondo magico, scegliendoli tra gli esempi di popoli che hanno vissuto esemplarmente l’esperienza drammatica della “crisi della presenza”: l’individuo che vacilla di fronte alla pressione della realtà naturale e rischia di esserne dissolto, ma con i riti e pensieri magici elabora una prima forma di reazione a quella crisi, e così riconsolida il suo essere al mondo. Possiamo ritrovare in noi quella crepa dell’esistenza, in momenti storici e individuali drammatici, e quelle foto possono allora ricordarci una capacità di resistere e passare oltre che è ancora nostra.
I souvenir, quindi, sono un bivio: possono restare muti, o aprirci al recupero di possibilità remote che sta a noi riprodurre – o piuttosto, reinventare. In questo somigliano alle radici, che mettono in collegamento con un terreno denso d’intrecci e connessioni, rendendo possibili nuove crescite, forme, abitudini. Gli abiti tradizionali, come le abitudini, si possono ereditare, e riportare addosso, ma anche modificare. Tutte le mode passano, e ogni cosa che per noi conta somiglia a una moda: col passare del tempo può apparire superata, incongrua. Ma ogni rinnovamento è radicato nei modelli precedenti, che possono tornare a fiorire in nuove forme. Ancora un’evoluzione che assomiglia a quella naturale, ma il modello di ciò che è stato – souvenir-radice – ci ispira e rivive in nuove forme, se non ci facciamo incantare dall’idea di un passato immobile.
Paolo Pecere
Università Roma Tre
Oggetto concepito per fare da ponte fra il presente e il passato soggettivo – come il diario, l’autobiografia e la lapide commemorativa, forme testuali che assolvono alla funzione di ‘ancoraggi’ a un passato che resta diverso da quello storico, perché costitutivamente incondiviso –, il souvenir ha natura parallela e speculare a quella dell’immagine devota e della reliquia. Se queste infatti convocano il pellegrino, lo chiamano a sé con la potenza centripeta del luogo sacro, con il souvenir è il mondo, o quantomeno il mondo esperito dal turista, a irrompere nello spazio domestico.
Letto sotto questa luce il souvenir tramuta il viaggio, un viaggio generalmente banale giacché appunto è la banalità a costituire la natura più vera del souvenir, in pellegrinaggio, laddove esso conferisce un senso alla visita compiuta a un luogo (ecco il sacro e l’ordinario convergere fino a toccarsi, probabilmente soltanto qui). Per questo esso non risponde, non deve rispondere, a canoni estetici, proprio come non lo fa l’immaginetta devozionale, il santino, che ripudia per mandato l’eventualità artistica al fine di veicolare il puro compito taumaturgico (compito per lo più perduto oggi, ma testimoniato dai miracoli di guarigione operati dalle immagini cartacee applicate al corpo sofferente di cui abbondano gli atti dei processi di canonizzazione). In entrambi i casi, la presenza del soggetto in un dato luogo (la meta turistica, la meta religiosa) e in un dato tempo (il tempo della vacanza, il tempo della devozione) è ciò che deve essere ricordato.
Il souvenir dunque ci parla, con la voce del passato: ci ricorda che ‘un giorno fummo là’. Per questo esso è oggetto antistorico, visto che la storia, a differenza della memoria, è vicenda ricomposta e narrata da chi non l’ha vissuta: il souvenir ha senso e ragione solo dove persiste una memoria del viaggio, più o meno lontana, più o meno palpitante, ma comunque personale. Evaporata questa esso smarrisce sé stesso, la propria ragion d’essere, e degrada rapidamente nel più puro e semplice kitsch. Anche in questa prospettiva il souvenir si sovrappone parzialmente all’immagine devota, che a sua volta riscuote riconoscimento finché è percepita come tale, finché evoca la presenza di chi ha fede e l’avvento del soprannaturale che soccorre.
Sono risvolti non semplici da comprendere per noi che viviamo in società del cambiamento, nelle quali la memoria, che vive di tempo profondo e prolungato, è sottoposta all’azione erosiva delle esigenze del consumo di informazione, che si nutre invece di immediatezza. La rimemorazione, che esige ruminazione e metabolizzazione del passato, ha un costo troppo alto per la cultura in cui siamo immersi: cibo indigesto, ciò che fu.
Un tale smarrimento della profondità aiuta a capire il vuoto scavato nello spazio del sacro, poiché l’operare della rimemorazione chiama sempre l’intervento di un ‘altro da noi’, il genio del ricordo. Come ci ha insegnato Jean-Pierre Vernant (Mito e pensiero presso i Greci, 1965), nelle società senza scrittura, che sono società di memoria, «il passato […] è molto di più che l’antecedente del presente: è la fonte di questo». Mnemosyne, nel pantheon greco, è la dea della memoria, e presiede alla funzione poetica laddove la parola evocatrice è sempre sacra, ed esercita potere nel paradigma della tradizione, la catena che stringe ciò che è presente a ciò che non lo è più. L’azione del soprannaturale, evidente, dirimente nel consumo delle immagini devozionali, è allora elemento imprescindibile della rimemorazione: il ‘sovvenire’, il ricordare (il souvenir, appunto), necessita di un aiuto esterno al soggetto. Il verbo latino originale, subvenire, sta sia per ‘presentarsi’ che per ‘soccorrere’, e in questo riflette l’idea di un operare del divino nella forma del soccorso, sempre indispensabile a legare presente e passato.
Tale gioco complesso di interrelazioni fra souvenir, esperienza e viaggio trova un fulcro fondamentale nella memoria condensata dal valore simbolico dell’oggetto. La memoria personale del viaggio, certo, dell’esperienza emotiva, o dell’esperienza di fede raccolta attorno all’immagine sacra. Ma non soltanto questo: perché la memoria, fissandosi in simboli condivisi e largamente standardizzati – e questo vale tanto per l’immaginario religioso, ampiamente noto e studiato nella sua simbolica, quanto per quello turistico, tanto che infallibilmente possiamo riconoscere un souvenir a colpo d’occhio, dalla sua sovraccarica estetica del banale – fa sempre affidamento su linguaggi condivisi, e dunque su una propria imprescindibile dimensione collettiva, quindi culturale.
Si deve al sociologo Maurice Halbwachs l’introduzione del concetto di ‘memoria collettiva’ in un lavoro dedicato un secolo fa ai «quadri sociali della memoria» (Les cadres sociaux de la mémoire, 1925): nelle scienze sociali entrò così la nozione fondamentale secondo la quale la memoria è sempre funzione socialmente condizionata, plasmata dal gruppo di appartenenza secondo precise coordinate culturali che rinviano il singolo alla comunità entro un processo di costruzione identitaria. È un processo che passa attraverso canoni visuali facilmente riconoscibili, seppure con difficoltà sempre maggiore: il profilo del campanile di Venezia e quello della torre Eiffel, la mole del Colosseo e quella dell’Empire State Building, le forme esili della gondola e del Manneken pis di Bruxelles, come pure le mani giunte di Padre Pio (san Pio da Pietrelcina, ufficialmente), gli occhi febbrili di san Francesco e il piede della Vergine che opprime il serpente antico.
Archetipi ancestrali, riconosciuti come tali da generazioni di viaggiatori e di pellegrini, in cerca di stupore o di guarigione (o delle due cose assieme); archetipi che compongono scenari dai quali lo spettatore è sempre assente, perché la sua posizione è quella dell’osservatore esterno che ricorda, e ricordando ricuce il senso del proprio essere in quel luogo e in quel momento. La composizione si è rovesciata, oggi: lo spettatore è sempre presente nell’immagine del selfie, nella quale il paesaggio e gli oggetti trovano un senso soltanto come sfondo dell’affermazione di un eterno presente che si alimenta di narcisismo.
Franco Motta
Università di Torino
Cartolinesco [car-to-li-né-sco] agg. m. – f. -a; pl.m. –schi, f. –sche. Che ricorda
una cartolina illustrata, e quindi di scarso valore artistico, di maniera: paesaggi cartolineschi.
Quando ho spedito l’ultima? Non riesco a ricordarlo. Delle cartoline, oggi, non sembra essere solo finita l’epoca, ma quasi cancellata la memoria. Resta solo sul dizionario il luogo comune di un nome e un aggettivo che richiamano qualcosa di banale, trito, kitsch. Non c’è pietà per i medium morti. Neppure per quelli che hanno invaso il mondo, strutturato relazioni fra milioni di persone, costruito un immaginario planetario: perché questo è stato la cartolina, medium di un secolo, il Novecento, molto più interconnesso di quello che credono, dall’alto dei loro display luminosi, i nativi digitali. E lo furono, così potenti, le cartoline, proprio perché furono così popolari, modeste, umili. “Spiccioli dell’arte e della cultura” le definiva Paul Eluard, che ne fu collezionista accanito.
Manufatti cartacei insignificanti? Ma non scherziamo. Furono oggetti culturali di una complessità che fa impressione. Un palinsesto inestricabile, una torta millefoglie
sociologica, una stratigrafia di usi privati e pubblici, iconografici e verbali, di segni idiolettici (il messaggio, le scritte, i disegni) e normativi (il francobollo, il timbro), di iscrizioni documentali di diverso spessore, pensate solo a quanti esseri umani servivano perché una cartolina dispiegasse la sua funzione: un fotografo, un ritoccatore, a volte un disegnatore, un editore, uno stampatore, un venditore, un mittente, un destinatario, diversi impiegati postali… Per non dire della seconda vita della cartolina, il bancarellaio, il collezionista, l’archivista, l’editore, lo studente, lo studioso… “In Italia ci sono troppi laureati in Lettere e pochi laureati in cartoline”, pare abbia detto Totò, ma che sia vera o apocrifa la battuta, è fantastica. Per fortuna ci furono e ci sono, quei laureati… Anzi, come mostra questa mostra, forse oggi la situazione è eccellente per studiarle: sosteneva Marshall McLuhan che la vera identità di un medium si scopre al suo tramonto.
Vero è che, strattonata nell’area del ricordo nostalgico, oggetto di troppi volumetti “BorgoCoso com’era”, “BorgoCoso d’una volta”, ha sofferto. Ma ha pagato, la cartolina, colpe largamente non sue. Sì, ci furono le cartoline sporcaccione, e quelle feroci, aggressive, bellicose. Ma anche quelle d’amore, o di vacanza, poeticamente ingenue. Riflettevano vizi e virtù degli uomini. Quanto alle cartoline più cartoline di tutte, quelle dei luoghi lontani, tutto quel che ebbero di stereotipo, e ovviamente ne ebbero tanto, le veniva dalla fotografia di paesaggio colta. In Italia, essenzialmente da quello stile Alinari (che pure ebbe i suoi quarti di nobiltà e la sua funzione storica) che isolava i monumenti dal contesto urbano, li trasformava in souvenir iconicamente ritagliati, asportabili, intercambiabili, astratti dalla vita e dall’uso.
E invece bastava guardarle, e guardarne tante, per capire che le cartoline furono un medium prismatico, polimorfo, contraddittorio, ambiguo, fertilissimo. Un medium corale, multisorgente, una vera wiki-visione pre-Web. Accanto alla consacrazione del tipo e dello stereotipo, accanto alla vivisezione della città, c’erano le cartoline dello scarto, del margine. Cartoline che contraddicevano la retorica del monumento, che si sottraevano alle gerarchie della città ufficiale, risignificando altri luoghi, quelli della vita quotidiana, dell’abitare, del lavorare, dello svagarsi. La cartolina ha cominciato a guardare la città vista ma non percepita molto prima degli intellettuali della visione: quando Luigi Ghirri guidò l’impresa del Viaggio in Italia, sapeva e riconosceva il debito.
È ora di restituire alle cartoline quel che appartiene loro. Non erano un sottoprodotto della
cultura visuale, erano protagoniste in prima persona di una trasformazione antropologica. Non registravano, ma intervenivano compensando, invocando, immaginando, proponendo. Ma lo facevano senza sapere di farlo.
Come tutti i medium, anche la cartolina è stata un campo di forze, un’arena simbolica
del confronto sociale. Non ne spediamo più? Ma davvero davvero? E cosa sono le immaginette Instagram che molliamo come palloncini nel cloud della Rete, ancora calde di clic smartphonico? Cosa sono le foto della nostra vita comune che appendiamo sui social con due righe di hashtag? Non sono i “saluti e baci” digitali di un’epoca smaterializzata? Cartolina, grazie di tutto, ma sappiamo che sei ancora fra noi.
Michele Smargiassi
Giornalista
DIDASCALIE VETRINA 7
I RICORDI PERSONALI
Da collezioni private
anni Sessanta-Novanta del Novecento
1
Bamboline con costumi tradizionali
dall’Italia, da vari paesi d’Europa e del mondo
Matrioska, tre pz.
Russia
2
Gondola
Venezia, Italia
Cuccù
Matera, Italia, anni Duemila
Trulli
Alberobello, Puglia, Italia
San Bernardo con cuccioli
Valle d’Aosta, Italia
Boule de neige
Campanella, casa di Giulietta e Romeo
Verona, Italia
Carretto siciliano
Sicilia, Italia
Fiammiferi
Superga, Italia
Piatto con Chimera
Arezzo, Toscana, Italia
Scatolina decorata con conchiglie
Italia, anni Cinquanta del Novecento
Grolla e coppa dell’amicizia
Valle d’Aosta, Italia, 1980
Pietà di Michelangelo, Bocca della verità, S. Pietro, Lupa Capitolina
Roma, Italia
3
Torre Eiffel
Parigi, Francia
Campana da mucca (cow bell)
Svizzera
Cucchiai in legno
Russia
Samovar
Russia
Fiammiferi
Russia
Pesce da appendere
Isola di Maui, Hawaii, 1993
4
Sari
India, Tamil Nadu, 2007
Abito da nubenda
Turchia, anni Duemila
Legature per trasporto a dorso d’asino
Turchia, anni Duemila
Copricapi
Fez, Turchia
Phareon (o fárion), copricapo rosso con nappa nera, degli Evzones, la guardia presidenziale greca
Basco, copricapo tradizionale della regione basca, in Spagna
1960-1971
Camicia con ricamo blu
Kiev, 1967
5
Madonna decorata con conchiglie
Italia, anni Cinquanta del Novecento
Conchiglia di Santiago di Compostela
Compostela, Spagna, anni Duemiladieci
Simbolo del Cammino di Santiago di Compostela, testimonianza dell’avvenuto pellegrinaggio
Indian Celestial Globe, ruota di preghiera e amuleto di carta
oggetti rituali buddisti tibetani
Ladakh, 1999
Madonna nera di Tindari
Tindari, Sicilia, Italia
Matite di Padre Pio
Pietrelcina, Italia
Sant’Antonio
Padova, Italia
6
Maneki Neko, gatto portafortuna giapponese
New York, USA, 2000
Servizio da sakè
Giappone
Servizio da tè in miniatura
con mobiletto a due cassetti con braciere, portafiori e pipa
Giappone
Carte per il gioco a sfondo letterario Hyakunin isshu, “100 poesie di 100 poeti”
Giappone
Fascia da kamikaze usata dagli studenti universitari in occasione degli esami
Tokyo, Giappone, 2012-2013
con la scritta 必勝 hisshou “vittoria certa”
Magnete per frigo con Takeda Shingen, grande generale e Daimyo, signore del sedicesimo secolo
Tokyo, Giappone, 2012-2013
Ventaglio con l’hinomaru (il Sol levante) dal Meiji Jingu, santuario di Tokyo dedicato all’imperatore Meiji
2012-2013
Ofuda
talismano preso al santuario di Atsuta
Nagoya, Giappone, 2012-2013
Portachiavi con Luffy, il protagonista del cartone One Piece
Nagoya, Giappone, 2012-2013
7
Amenity kit
Kit di cortesia
Souvenir aziendale Alitalia
1993-1995
Borsa da viaggio
Souvenir aziendale Alitalia
8
Merchandising museale