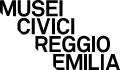7 – L’abito-souvenir: radici di identità e creatività
Un focus particolare sul tema dell’abito-souvenir, oggetto che accompagna il viaggio sia del turista che del migrante: un percorso visivo dedicato a tessuti, abiti e accessori, nato da un progetto partecipativo che ha coinvolto otto associazioni interculturali di Reggio Emilia collegate ad altrettanti Paesi della diaspora: A.B.R.E.E.R. – Associazione dei cittadini del Burkina Faso di Reggio Emilia e dell’Emilia Romagna, Associazione maliana Badegna, Associazione dei Nigeriani di Reggio Emilia e provincia, Associazione per lo sviluppo della comunità Tamil del territorio reggiano, Associazione filippina Bahaghari, NSAA Kente Group, Associazione moldava Plai e Associazione albanese Shqiponja.
Le associazioni partecipanti sono detentrici dei saperi e dei significati simbolici e spirituali legati ai tessuti e ai modi di vestire di diverse zone geografiche del mondo, ma anche di memorie affettive e familiari collegate ai capi esposti.
Gli abiti non sono semplici reperti: appartengono a vissuti personali, rimandano a spostamenti internazionali, sono alcuni degli elementi attorno a cui si costruisce la dimensione associativa e conservano un legame intimo con chi li ha indossati o li ha ricevuti in dono e scelti per l’esposizione in mostra. Alcuni capi portano con sé anche la complessa eredità coloniale e processi di ridefinizione dei significati legati alle pratiche dell’abbigliamento.
Il percorso espositivo invita a superare l’idea statica di “costume tradizionale”, che può portare con sé delle visioni stereotipate sulle persone che lo indossano. Come le identità, l’abbigliamento è un campo dinamico e composito, in cui la tradizione si trasforma coerentemente con le evoluzioni sociali che influenzano gusti e pratiche del vestire.
Aprire gli immaginari significa decostruire immagini consolidate e interrogarsi su ciò che i tessuti e la loro storia raccontano, lasciandosi guidare da chi ha scelto cosa esporre e condividendone con il pubblico i significati.
Indossare un abito non è mai solo celebrare un rito o evocare un passato: è un corpo che si autorappresenta e si comunica per come vuole essere riconosciuto nella sfera delle relazioni sociali. Nelle mani di stilisti e sarti della diaspora, alcuni anche attivi in Italia, gli abiti e i tessuti vengono reinterpretati e diventano parte integrante del presente. Indossati in modi personali e creativi, continuano a raccontare identità vive e in movimento.
Nel percorso di mostra gli abiti delle comunità residenti a Reggio Emilia sono posti in dialogo con altri abiti della creatività professionale contemporanea – prototipi realizzati dagli studenti del Master in Creative Knitwear Design di Accademia Costume & Moda, in collaborazione con Modateca Deanna – che mostrano anch’essi evidenti tracce di persistenze e contaminazioni culturali, in cui sono ben riconoscibili identità e radici.
DIDASCALIE VETRINA 10
L’ABITO-SOUVENIR: RADICI DI IDENTITÀ E CREATIVITÀ
1 – Abito femminile in tessuto Luili Pende
Burkina Faso
Ispirato alla moda degli anni Novanta
Il Luili Pende è uno dei tessuti più affascinanti e simbolici del Burkina Faso. Le sue origi-ni sono nel cuore delle comunità Mossi e Bobo, dove tessere e tingere non era soltanto un’attività artigianale, ma una forma di espressione sociale e spirituale.
Il processo di realizzazione è lungo e meticoloso. Si parte dalla selezione del cotone locale, fiocco dopo fiocco, cercando la fibra più morbida e resistente. Questo cotone viene poi filato a mano con strumenti tradizionali, fino a ottenere lunghi fili uniformi, pronti per essere intrecciati sul telaio. I telai sono strumenti antichi, spesso costruiti in legno massiccio. L’arte del telaio non consiste solo nel mettere i fili in sequenza, ma nell’intrecciarli seguendo schemi che determinano motivi geometrici, simboli culturali e significati profondi.
Un elemento fondamentale del Luili Pende è il colore. I colori sono ottenuti principalmente con pigmenti naturali, estratti da radici, cortecce, foglie o minerali. Queste tinture non sono solo estetiche: in molte comunità, i colori hanno significati precisi. Il rosso può simboleggiare il coraggio e la vitalità, il blu la pace e la serenità, il bianco la purezza e la spiritualità. Il tessuto diventa così un linguaggio visivo, attraverso cui si comunicano valori, credenze e appartenenza sociale.
Il Luili Pende ha una funzione sociale ed è usato in cerimonie religiose, matrimoni, riti di passaggio e celebrazioni comunitarie. Ogni motivo sul tessuto può avere un significato: un simbolo ripetuto può rappresentare la protezione degli antenati, una combinazione di forme geometriche può raccontare la storia di un villaggio o di una famiglia. Durante le feste, uomini e donne indossano i Luili Pende con orgoglio.
L’aspetto estetico è legato a motivi, spesso geometrici, che si susseguono. Alcuni Luili Pende presentano dettagli più elaborati, con piccoli disegni che richiamano elementi della natura, animali o strumenti musicali locali. Questa attenzione al dettaglio fa sì che ogni tessuto sia unico, un oggetto d’arte tessile, oltre che un capo funzionale.
Negli ultimi decenni, il Luili Pende ha vissuto un periodo di rinnovato interesse, sia in Burkina Faso che a livello internazionale. Designer e stilisti hanno iniziato a valorizzare questo tessuto, reinterpretandolo in chiave contemporanea.
Il Luili Pende è simbolo di identità e resistenza culturale. Ogni volta che viene tessuto, indossato o mostrato, racconta storie di persone, luoghi e tradizioni, rendendo tangibile l’eredità delle comunità del Burkina Faso.
*
*
2 – Abito femminile in tessuto Kôkô Dunda
Burkina Faso
Anno 1995
Il Kôkô Dunda ha radici profonde nella città di Bobo-Dioulasso. Il suo nome, che letteralmente significa “la collina di Kôkô”, richiama la zona in cui i primi artigiani sperimentarono le tecniche di tintura e tessitura che oggi rendono il Kôkô Dunda famoso. Questo tessuto è noto per la sua eleganza sobria, i suoi motivi geometrici intricati e la vibrante armonia dei colori.
La produzione del Kôkô Dunda richiede una conoscenza approfondita dei filati e delle tecniche di tintura a riserva. Gli artigiani scelgono con cura il cotone locale, lavorandolo a mano per ottenere una fibra uniforme, pronta a essere intrecciata sul telaio. La caratteristica principale del Kôkô Dunda è la capacità di combinare motivi geometrici regolari con variazioni sottili che rendono ogni pezzo unico. Gli schemi decorativi riflettono simboli culturali, miti, leggende locali e valori sociali.
Il colore è un elemento centrale. Gli artigiani impiegano pigmenti naturali, spesso derivati da piante autoctone o terre locali. Il blu profondo, simbolo di pace e spiritualità, il rosso acceso, legato al coraggio e alla forza, e il giallo brillante, che rappresenta la prosperità e la fertilità, si combinano armoniosamente. La scelta dei colori e la disposizione dei motivi racconta una storia precisa, un messaggio nascosto o un sentimento da trasmettere, rendendo ogni Kôkô Dunda un documento vivente della cultura bobo.
Il Kôkô Dunda ha una funzione sociale molto rilevante, perché simbolo di appartenenza e di status. In occasione di cerimonie importanti come matrimoni, rituali di passaggio o celebrazioni comunitarie, uomini e donne indossano il Kôkô Dunda con orgoglio, mostrando il legame con le tradizioni e la propria famiglia. Alcuni motivi e combinazioni di colori possono indicare il rango sociale o la provenienza di chi lo indossa.
Oltre alla sua valenza sociale e simbolica, il Kôkô Dunda è anche una valenza estetica. Le trame dense, i motivi regolari e la precisione dei disegni riflettono l’abilità dei tessitori. Alcuni Kôkô Dunda presentano dettagli più elaborati, come figure stilizzate o simboli ispirati alla fauna e alla flora locali. Negli ultimi decenni, il Kôkô Dunda ha conosciuto una nuova vitalità grazie all’interesse di designer, stilisti e istituzioni culturali. Molti giovani artigiani hanno iniziato a reinterpretare il tessuto in chiave contemporanea e questa rinascita ha permesso al Kôkô Dunda di conquistare nuovi mercati e di diventare un ambasciatore della cultura burkinabé nel mondo.
*
*
3 – Abito femminile in tessuto Faso Dan Fani
Burkina Faso
Ispirato alla moda degli anni Sessanta
Il Faso Dan Fani, che in lingua dioula significa letteralmente “il tessuto tessuto dalla dignità”, è forse il simbolo più potente dell’identità culturale del Burkina Faso. Non è solo un’opera artigianale, ma un emblema nazionale, testimone della storia, della resilienza e dell’orgoglio di un popolo.
Il tessuto è realizzato con cotone locale, raccolto a mano e filato su telai tradizionali secondo schemi precisi, creando trame regolari che conferiscono al tessuto forza e armonia. I motivi del Faso Dan Fani sono riconoscibili per la loro semplicità elegante e per l’alternanza di righe e linee, spesso di colore bianco e blu o bianco e nero, che evocano il ritmo della vita quotidiana e la connessione con la terra. Questi schemi non sono solo decorativi: molti motivi portano con sé significati ancestrali, raccontando storie di comunità, cicli agricoli e legami familiari.
Storicamente, il Faso Dan Fani ha assunto un ruolo politico e culturale di primaria importanza durante il periodo di governo di Thomas Sankara, negli anni ’80. Sankara promosse il tessuto come simbolo di identità nazionale e di autonomia economica, incoraggiando la popolazione a preferire il tessuto locale a quelli importati. In questo contesto, il Faso Dan Fani non divenne solo un tessuto da indossare, ma un segno di orgoglio patriottico, di appartenenza e di sostegno all’artigianato nazionale. Ancora oggi, indossare un Faso Dan Fani può essere interpretato come un atto di valorizzazione della cultura e delle tradizioni del Burkina Faso.
Il tessuto ha anche una funzione sociale. Viene utilizzato in cerimonie importanti, come matrimoni, nascite e eventi religiosi. Le famiglie scelgono i motivi e i colori in base al significato che intendono comunicare. I pezzi più pregiati sono spesso tramandati di generazione in generazione, diventando preziosi patrimoni familiari. Il Faso Dan Fani, quindi, è un testimone della storia personale e collettiva e racconta il legame tra passato, presente e futuro.
Sebbene sembri semplice a prima vista, osservandolo si apprezza la maestria dell’artigiano: le variazioni sottili dei motivi, l’equilibrio tra colori chiari e scuri e la consistenza uniforme del tessuto testimoniano grande abilità tecnica.
Tessuto ammirato sia a livello nazionale che internazionale, negli ultimi anni ha conosciuto un rinnovato interesse anche fuori dal Burkina Faso. Designer e stilisti lo hanno reinterpretato in chiave moderna, creando abiti, accessori e tessuti d’arredo. Questa fusione di antico e moderno consente di valorizzare l’artigianato locale, garantendo allo stesso tempo nuove opportunità economiche agli artigiani.
*
*
4 – Saponé
Cappello
Burkina Faso
Il cappello Saponé può assumere forme leggermente diverse, è realizzato a mano intrecciando paglia e decorato con cinghie di cuoio. Non è solo un accessorio funzionale per proteggersi dal sole, ma un simbolo di identità culturale e orgoglio nazionale, tanto da aver ottenuto il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP), a tutela della sua autenticità e per proteggerlo dalla contraffazione.
*
*
5 – Sãah tõkõh o Ssãah kêh
Faretra, etnia Mossi
Burkina Faso
La faretra è nota in lingua bissa come sãah tõkõh o ssãah kêh. Realizzata principalmente con materiali naturali come il bambù e talvolta decorata con incisioni o motivi simbolici, serve a contenere i dardi delle cerbottane, molti dei quali erano tradizionalmente avvelenati. Le faretre sono fissate alla cintura del cacciatore tramite ganci intagliati in legno, spesso decorati con disegni protettivi raffiguranti animali o simboli spirituali, destinati a proteggere chi li porta da sfortune e spiriti maligni. L’interno della faretra può contenere una custodia in cuoio che protegge i dardi, assicurandone la sicurezza e la praticità. La storia di questo oggetto risale al XIV secolo ed è strettamente legata alle cerimonie di intronizzazione degli imperatori Mossi, ma ha anche avuto un ruolo quotidiano nella caccia e nella sopravvivenza nelle comunità rurali.
*
*
6 – Calebasse
Burkina Faso, etnia Peuhl
Elemento fondamentale della cultura materiale burkinabé è la calebasse, una zucca africana tradizionalmente utilizzata come contenitore per acqua, cibo o latte, come facevano storicamente gli allevatori Peulh. Tuttavia, la sua funzione non si limita alla vita quotidiana ma può diventare uno strumento musicale, fungendo da cassa di risonanza per la kora o il balafon o da percussioni nelle danze e nelle cerimonie. Le calebasse possono anche essere trasformate in oggetti decorativi mediante incisioni o pirografia, assumendo così una funzione estetica e simbolica. In alcune culture, come quella dei Peulh o dei Foulfundé, la calebasse rappresenta la matrice femminile e l’universo, entrando a far parte del corredo della nuova sposa e simboleggiando fertilità, protezione e connessione con la natura e la comunità.
1 – Maglia tradizionale maschile in tessuto Wax
Mali, Africa Occidentale – Cultura mandinga e bambara
La maglia è realizzata in tessuto wax, un cotone stampato a cera tipico dell’Africa occidentale, riconosciuto per i suoi colori vivaci e i motivi geometrici regolari. Il disegno di questo completo presenta una composizione a blocchi rettangolari multicolori nei toni del verde, turchese, fucsia, arancio e nero, creando un effetto visivo dinamico e simbolico. Il wax è spesso associato a valori culturali, familiari o sociali, poiché ogni motivo può portare un significato legato alla vita quotidiana, alla prosperità o all’unità familiare. In questo caso, il set composto da una maglia per adulto e una per bambino sottolinea la trasmissione generazionale e il legame familiare. Il taglio semplice e lineare è tipico dell’abbigliamento maschile quotidiano o delle celebrazioni informali, mantenendo un equilibrio tra eleganza e praticità.
*
*
2 – Boubou maschile in Bazin Riche
Completo maschile in bazin blu
Mali, Africa Occidentale – Cultura mandinga e bambara
Questo completo maschile, costituito da una tunica ampia e un pantalone, è realizzato in Bazin Riche, un tessuto di cotone lucido e rigido, tipicamente tinto a mano con la tecnica detta teinture. Il colore blu intenso e le decorazioni ricamate sul petto testimoniano la raffinatezza e l’importanza di questo indumento, spesso riservato a occasioni cerimoniali o religiose come matrimoni, feste islamiche o celebrazioni comunitarie. Il bazin, noto per la sua brillantezza e la sua texture lucida, è considerato un simbolo di prestigio e rispetto sociale. L’abito rappresenta il connubio tra la tradizione sartoriale africana e l’eleganza contemporanea, mantenendo la tipica vestibilità ampia del boubou, che consente libertà di movimento e dignità nella postura.
*
*
3 – Abito femminile da cerimonia in Bazin Riche
Abito femminile in bazin blu con decorazioni dorate
Mali, Africa Occidentale – Cultura mandinga e bambara
Questo elegante abito lungo da donna è confezionato in Bazin Riche, arricchito da ricami dorati realizzati a mano lungo il corpetto, la vita e l’ampia gonna a sirena. Il tessuto, rigido e lucente, è uno dei più pregiati della tradizione maliana, utilizzato per matrimoni, battesimi e feste religiose. I motivi dorati, che evocano foglie stilizzate e forme geometriche, simboleggiano la bellezza e la prosperità, valori profondamente radicati nella cultura locale. L’abito, grazie alla sua struttura aderente sul busto e svasata verso il fondo, esalta la figura femminile pur mantenendo la solennità richiesta nelle occasioni formali. Questo tipo di confezione rappresenta una fusione tra tradizione e moda contemporanea africana, con un forte valore identitario.
*
*
4 – Abito femminile tradizionale in tessuto wax
Abito femminile in tessuto wax a motivi geometrici e floreali
Mali, Africa Occidentale – Cultura mandinga e bambara
Questo abito femminile è confezionato in tessuto wax, un cotone stampato a cera tipico dell’Africa occidentale, noto per la sua brillantezza e la complessità dei motivi. Il disegno presenta fasce verticali nei toni del fucsia, turchese e bianco, ornate da motivi ornamentali blu e neri che evocano forme di fiocchi e intrecci floreali. Il contrasto cromatico e la simmetria del motivo sono elementi distintivi del wax, che unisce estetica e simbolismo. L’abito, dal taglio lungo e svasato nella parte inferiore, è tipicamente indossato in occasioni festive o cerimonie comunitarie, valorizzando la grazia e l’eleganza della figura femminile. Il wax utilizzato, resistente e luminoso, riflette anche un senso di orgoglio identitario e appartenenza culturale, poiché ogni stampa racconta una storia o trasmette un messaggio sociale.
1 – Agbada, abito maschile e abito femminile
Nigeria sud-occidentale, popolo Yoruba
Tradizione attestata dal XV secolo
L’Agbada è una maestosa tunica cerimoniale maschile, simbolo di dignità, potere ed eleganza. Appartenente alla cultura Yoruba, uno dei quattro principali gruppi etnici della Nigeria, questa veste rappresenta una dichiarazione di identità e orgoglio culturale.
L’abito è composto da quattro elementi: la veste esterna, ampia e fluente fino alle caviglie, con maniche larghe e una sezione centrale rettangolare decorata da ricami e motivi colorati; la tunica interna, più aderente, indossata sotto l’abito principale; i pantaloni “Shokoto”, larghi e lunghi; il copricapo “Fila”, coordinato con l’abito.
Tradizionalmente indossata in occasione di matrimoni, cerimonie religiose e funerarie, l’Agbada si distingue per i suoi ricami intricati, le perline di vetro e altri elementi ornamentali.
*
*
2 – Isi Agu, abito maschile
Nigeria sud-orientale, popolo Igbo
L’Isi Agu, letteralmente “testa di tigre”, è un tessuto e un capo d’abbigliamento di grande significato nella cultura Igbo. Il motivo che lo caratterizza, la testa del felino, simboleggia forza, nobiltà e coraggio, virtù fondamentali nella società Igbo.
L’indumento si presenta con una camicia o una casacca ed è considerato un “classico senza tempo”, espressione di status, eleganza e appartenenza culturale. Indossato durante celebrazioni e incontri solenni, l’Isi Agu testimonia la ricchezza simbolica della tradizione tessile Igbo.
*
*
3 – Aso Oke, abito maschile e abito femminile
Nigeria sud-occidentale, popolo Yoruba
L’Aso Oke è un tessuto tradizionale intrecciato a mano, utilizzato per abiti cerimoniali Yoruba. Il suo nome significa “vestito del nord” e rappresenta un simbolo di status, identità e tradizione.
Indossato in occasioni come matrimoni, funerali, incoronazioni e feste religiose, l’Aso Oke è anche legato al concetto di solidarietà comunitaria, espresso nelle uniformi cerimoniali dette “Aso Ebi”. In ambito religioso, è associato ai costumi degli Egungun, le maschere che incarnano gli spiriti degli antenati.
La sua realizzazione, affidata ad abili artigiani, prevede la filatura manuale del cotone e la tessitura su telai tradizionali, in un processo lungo e laborioso.
*
*
4 – Igbulu e Ijakpa, abito maschile
Nigeria,Stato di Edo, popolo Esan
L’Igbulu, noto anche come Igbu, è l’abito tradizionale del popolo Esan. Realizzato su telai artigianali con fili spessi e colorati, rappresenta orgoglio, identità e appartenenza etnica.
L’abito è completato dall’Ijakpa, una veste in pelle animale che possiede anche un significato spirituale e protettivo.
Le donne Esan spesso adornano il corpo con collane di pelle (Akpono) e applicano gesso bianco come trucco rituale, segno di gioia e prosperità, soprattutto in occasione di nascite o festività.
L’Igbulu e l’Ijakpa sono indossati durante matrimoni tradizionali, cerimonie di titoli onorifici (chieftaincy) e riti di passaggio come simbolo dell’identità culturale Esan.
1 – Abito femminile Sari
Sri Lanka
Il sari o in tamil pudavai (Tamil: புடவை), è un indumento tradizionale femminile del subcontinente indiano e dello Sri Lanka le cui origini risalgono al 100 a.C., intuibilmente uno dei pochissimi indumenti ad essere stato tramandato per così tanti secoli. Consiste in una fascia di stoffa larga circa un metro, la cui lunghezza può variare dai quattro ai nove metri, che viene avvolta intorno al corpo dell’indossatrice con metodi che variano a seconda della sua funzione. Composto da tre parti: il sari, la camicetta e la gonna. Esiste sia per donne adulte che per bambine.
Nella storia dell’abbigliamento indiano, del sari si hanno tracce nella Civiltà della valle dell’Indo, che fiorì intorno al 2800-1800 a.C. nella parte nordoccidentale del subcontinente indiano. Il cotone inizia ad essere coltivato e tessuto nel subcontinente indiano intorno al V millennio A.C. e la seta intorno al 2450 a.C. e 2000 a.C. I coloranti utilizzati in questo periodo, sono in uso ancora oggi, in particolare l’indaco, la lacca, la rubia e la curcuma. La più antica rappresentazione conosciuta del sari nel subcontinente indiano è la statua di un sacerdote della Valle dell’Indo coperto da un drappo di stoffa.
*
*
2 – Abito maschile Veshti
Sri Lanka
Un veshti (Tamil: வேட்டி), noto anche come vēṭṭi , è un velo di stoffa bianca non cucito per la parte inferiore del corpo, usato nel Tamil Nadu e nel nord e nell’est dello Sri Lanka. Il vēṭṭi fa parte dell’abbigliamento tradizionale del subcontinente indiano e dello Sri Lanka. L’indumento è un singolo pezzo di stoffa, uno dei primi indumenti drappeggiati dell’India. Un vēṭṭi è spesso stratificato con strisce orizzontali o bordi per tutta la sua lunghezza.
Come molti abiti avvolgenti, il vēṭṭi varia nello stile con cui viene indossato. Spesso è semplicemente avvolto intorno alla vita, fissato da un angolo infilato sotto il tessuto avvolto. Una cintura viene anche utilizzata sopra di esso (meno popolare ora) appena sotto la chiusura. Esistono diversi stili con cui si può indossarlo. Esiste sia per adulti che bambini.
*
*
3 – Abito per bambina Pavadai sattai
Sri Lanka
Gonna e camicetta (Tamil: பவாடை சட்டை), è un abito tradizionale indiano, soprattutto del sud dell’India e Sri Lanka, indossato da ragazze e bambine, ed è il primo passo per vestire il sari da adulti. Consiste in una gonna (paavadai) e una blusa (sattai), completata da uno scialle (davani) che viene drappeggiato su una spalla.
*
*
4 – Abito per bambino Veshti
Sri Lanka
1 – Filipiniana, abito femminile
Filippine – Luisinana, Laguna; Italia – Bologna
Anni Sessanta
Descrizione abito (tessuto utilizzato, ricami presenti, eventuali decorazioni, stampe, significato dei motivi presenti, occasioni in cui viene indossato, ecc.)
L’abito rappresenta una versione contemporanea del Filipiniana, un tradizionale abito femminile filippino, ed è realizzato con il tessuto banig. Il banig è un materiale intrecciato a mano con foglie di pandano, una pianta che cresce spontaneamente lungo le coste e le spiagge sabbiose. La sua lavorazione artigianale richiede diverse settimane: le foglie vengono tagliate, bollite, essiccate, appiattite e ridotte in sottili strisce che, dopo la tintura con colori naturali o chimici, vengono intrecciate per ottenere un tessuto resistente, rigido ma flessibile, conferendo all’abito struttura e raffinatezza.
Il tessuto di questo abito è stato acquistato in un mercato di Lucena City e successivamente lavorato a Bologna dalla stilista di origine filippina Annie Capres, in collaborazione con Juliet Daylo, che ha realizzato gli accessori coordinati – orecchini, scarpe e ombrello.
L’abito Filipiniana ha origine dai tradizionali baro e saya: baro è una blusa leggera, spesso ricamata, e saya è una lunga gonna a campana. Nel corso dei secoli, anche sotto l’influenza del dominio coloniale spagnolo, questi capi si sono evoluti in forme moderne del Filipiniana, mantenendo la loro identità e adattandosi ai gusti e alle tendenze della moda.
Nel 2025, l’abito è stato indossato in occasione della Festa dell’Indipendenza delle Filippine celebrata a Ferrara, ed è stato scelto come l’abito più rappresentativo della cultura filippina tra quelli presentati dalle associazioni diasporiche dell’Emilia-Romagna.
Oltre agli eventi culturali, gli abiti in banig vengono comunemente indossati nelle processioni religiose, nei concorsi di bellezza e durante il Pahiyas Festival, la festa annuale del raccolto che celebra creatività e gratitudine.
*
*
2 – Barong Tagalog, camicia maschile
Filippine – Batangas City
Anno: 2017
Descrizione abito (tessuto utilizzato, ricami presenti, eventuali decorazioni, stampe, significato dei motivi presenti, occasioni in cui viene indossato, ecc.)
La camicia maschile esposta, nota come Barong Tagalog, è realizzata in Piña Silk, un tessuto pregiato ottenuto dalle sottili fibre delle foglie di ananas. Si tratta di una creazione dello stilista Renee Saloud, designer noto per il suo impegno nella reinterpretazione contemporanea degli abiti tradizionali filippini. Saloud collabora attivamente con le associazioni della diaspora filippina in Italia e realizza abiti su misura che mantengono vivi i simboli e le tecniche del patrimonio sartoriale filippino.
La camicia firmata Saloud è stata indossata nel 2017 al concorso di cultura filippina Balik Sa Basik (Ritorno alle origini), a Modena. La reinterpretazione dello stilista testimonia la capacità di far dialogare la tradizione con contesti contemporanei e internazionali.
Il Barong Tagalog è un capo che simboleggia l’identità filippina e viene indossato in occasioni formali come matrimoni, eventi culturali e diplomatici; viene abbinato a pantaloni di cotone o raso. Il tessuto, spesso arricchito da ricami elaborati, può essere realizzato anche con fibre di abaca o banana.
1 – Kente Adinkra
Kente tradizionale
Bonwire, Ejisu-Juaben, Regione Ashanti del Ghana
Anno, 2008
Il Kente deriva dalla parola “Kenten” che significa cesto. Il Re Ashanti ne indossa uno con i tipici simboli Adinkra. Sono presenti simboli come “Gye Nyame”, che simboleggia l’onnipotenza di Dio, e “Akofena”, le due spade incrociate, che simboleggiano coraggio e potenza. I gioielli del re vengono chiamati “Regalia Abbagliante d’Oro” oppure “Nkepo” perché in oro puro. Le fasce nere e oro della la testa, dei polsi e del petto hanno una simbologia: il collegamento tra il mondo spirituale ed il mondo ancestrale per quanto riguarda il nero; invece, per l’oro, sono talismani e amuleti che simboleggiano la sua autorità. La collana a forma triangolare è chiamata “Akrafokonmu”, deriva da “akra”, ovvero anima, e ha il compito di proteggere l’anima del re contro ogni attacco maligno.
I sandali, chiamati “Kyaw Kyaw”, sono creati con legno, ricoperti da pura pelle e decorati con talismani e amuleti che simboleggiano la ricchezza del re. La forma a 8 del sandalo rappresenta la stabilità e la continuità della tradizione e della cultura ashanti.
*
*
2 – Kente Nsasawa
Kente tradizionale
Bonwire, Ejisu-Juaben, Regione Ashanti del Ghana
Anno, 1900
Kente chiamato “Nsasawa”, ovvero “miscuglio”, con ricami a strisce dette cinture. La tradizione narra che le Regine non possano forare le orecchie, fare tatuaggi e treccine, perché devono avere un’acconciatura chiamata: “Densinkran”, che significa “La corona danzante”. Quest’ultima simboleggia lo status regale delle regina Ashanti.
Il suo abito è adornato da bracciali e perle in puro oro che rappresentano la sua ricchezza. Uno dei gioielli principali della regina Ashanti viene chiamato “Tassie”; i tessuti infilati alla sua vita vengono chiamati “Ani bere a enso gya” (serietà senza occhi rossi), “Sika tuo”(soldi con il botto) e “Ballon” (palloncino).
Questo Kente presenta i simboli Adinkra (arrivederci) con profondi significati come “Gye Nyame”, ovvero l’onnipotenza di Dio, oppure “Akofena”, le spade incrociate che simboleggiano la sua potenza e autorità.
I sandali reali chiamati “Ahenema” o “sandali dei soldi” sono di legno e pura pelle e sono decorati con oro puro, talismani e amuleti che simboleggiano ricchezza.
*
*
3 – Kente Edweneasa oppure Faprenu
Rivisitazione moderna maschile
Bonwire, Ejisu-Juaben, Regione Ashanti del Ghana
Anno, 1900
Questo Kente è uno dei primi ad essere creato con un nuovo motivo, poiché i materiali principali per la sua tessitura erano esauriti.
L’Edweneasa viene creato con tre fili di cotone ed è considerato uno dei più belli.
Il Kente viene tessuto con un telaio in legno e la leggenda narra che questi tessuti possono essere solamente creati dagli uomini. Infatti, la tradizione racconta che la nascita del Kente risale alla storia di due fratelli che si sono imbattuti in un ragno mentre tesseva la sua ragnatela; da lì è nata l’ispirazione per creare il Kente.
Questo, in particolare, è una rivisitazione moderna a stampa su cotone, fatto su misura e composto da camicia e pinocchietti, perciò la sua lavorazione non è così complicata come quello tradizionale.
Questo Kente viene indossato in occasione di battesimi, matrimoni, inaugurazioni e altre cerimonie.
*
*
4 – Kente Edwinisi Edwiniso
Rivisitazione moderna femminile
Bonwire, Ejisu-Juaben, Regione Ashanti del Ghana
Anno,1925
Uno tra più antichi Kente, è realizzato con una tecnica chiamata a cinque, a due e a tre per creare il motivo al suo interno. L’Edwinisi Edwiniso è molto apprezzato per la sua composizione geometrica.
Il significato dei motivi viene definito “l’incontro delle menti”, perché nel momento in cui due menti si confrontano, indipendentemente dalla diversità dei loro pensieri, si arriva sempre ad un fine comune. La sua lavorazione non è semplice, per creare questo particolare intreccio ci vuole molta pazienza.
Questo Kente è una rivisitazione moderna, perché è stato cucito su misura e composto da una blusa foderata e una gonna ampia foderata. Viene indossato in occasione di battesimi, matrimoni, inaugurazioni e altre cerimonie.
1 – Set di costumi nazionali
Anni Trenta del Novecento
Negli anni Trenta, il costume maschile, confezionato interamente in lana, era composto da cinque elementi: una camicia ornamentata con motivi geometrici eseguiti a mano con filo nero, un paio di pantaloni classici, una giacca lunga decorata con disegni geometrici utilizzando il filo nero, una cintura pesante (brâu) ricamata a mano e una tracolla (trăistuța) che riprendeva gli ornamenti principali dell’insieme. Il contrasto tra il bianco e il nero evocava due valori fondamentali: la libertà, rappresentata dal bianco, e l’eleganza, simboleggiata dal nero.
Il costume femminile dello stesso periodo, realizzato con materiali analoghi, esprimeva la stessa armonia di forme e significati. Era composto da una camicetta (ie) in cotone finemente decorata con figure geometriche, una sottogonna bordata di pizzo, una gonna (fotă) in lana con grosse rigature verticali e una cintura (brâu) rossa in lana.
*
*
2 – Costume femminile
Moldavia
Anni Trenta del Novecento
Nelle giornate estive o particolarmente calde, le donne preferivano un abbigliamento più leggero, confezionato in lino bianco e nero.
Questo costume era composto da una camicetta (ie) in lino bianco, ricamata con motivi geometrici che alludevano all’equilibrio e alla sicurezza, da una sottogonna in lino leggero, ornata di trine e pizzo all’orlo e da una gonna (catrinţă) in lino nero, arricchita da delicati fili d’oro che riprendevano gli stessi motivi della camicetta.
*
*
3 – Costume femminile
Moldavia
anni Cinquanta del Novecento
Negli anni Cinquanta, il costume nazionale da donna si semplifica, pur mantenendo il suo valore simbolico e ornamentale.
Realizzato in cotone, era composto da una camicetta (ie) bianca, ricamata con motivi vegetali: foglie di vite e grappoli dorati, simboli di purezza spirituale e fertilità. A completare l’insieme, una gonna (fotă) in cotone nero pesante, decorata con gli stessi motivi della camicetta. Il nero, colore dominante, simboleggiava la devozione alla terra e al lavoro agricolo, mentre il bianco evocava la spiritualità e la purezza femminile. Questo costume era indossato principalmente dalle donne durante le stagioni di passaggio – in autunno e in primavera – e in occasione di feste o cerimonie familiari.
*
*
4 – Set di abiti moderni
Moldavia
Anni Novanta del Novecento
La tradizione si rinnova, trovando nuove forme di espressione. Infatti, negli anni Novanta nasce una versione moderna del costume nazionale, in seta bianca, destinata alle occasioni festive e cerimoniali.
L’abito lungo femminile, dalle linee eleganti e contemporanee, presenta spalle traforate in pizzo, una cintura sottile che segna la vita e raffinati fregi floreali che si estendono dalle maniche e dal petto fino all’orlo.
Il linguaggio simbolico resta però fedele alle radici: le rose rosa rappresentano il sentimento passionale, mentre le foglie verdi evocano la vitalità e la rinascita.
Nel set vi è anche una camicia maschile in seta bianca, decorata con gli stessi motivi floreali, segno di armonia tra i due abiti e tra i due ruoli.
Entrambi venivano indossati da giovani uomini e donne in occasione di matrimoni o battesimi.
1 – Abito femminile Dimiq Mermeri
Tirana, Albania
Il Dimiq Mermeri rappresenta uno degli abiti tradizionali più pregiati della città di Tirana.
Realizzato in seta, questo abito è interamente decorato e ricamato a mano con filo d’oro, testimonianza dell’eccellenza artigianale albanese del periodo.
Il completo comprende gilet, coprigambe e numerosi elementi ornamentali riccamente lavorati.
Tradizionalmente, veniva indossato dalla sposa nel giorno del matrimonio, simboleggiando purezza, eleganza e prestigio familiare.
Il Dimiq Mermeri riflette la raffinatezza del costume nuziale femminile di Tirana nella metà del XX secolo.
*
*
2 – Abito maschile Giublet burrash
Tirana, Albania
Questo abito cerimoniale maschile, originario della capitale albanese, era utilizzato durante le nozze e altre occasioni solenni.
Il copricapo è realizzato in lana pressata, mentre la kamica (camicia) è confezionata in cotone.
I pantaloni, anch’essi in lana pressata, presentano decorazioni a strisce nere che ne evidenziano la struttura.
Il gilet, realizzato in stoffa di lana nei colori rosso e nero – simboli della bandiera nazionale albanese – è ricamato a mano con filo d’oro, a rappresentare forza, dignità e orgoglio patriottico.
L’insieme costituisce un importante esempio del costume tradizionale maschile di Tirana nella prima metà del XX secolo.
1
Frammenti d’amore
Industry Project Antonio Marras, designed by Domitilla Damiani
Master in Creative Knitwear Design di Accademia Costume & Moda
in collaborazione con Modateca Deanna
2
Volcano
designed by Fracesca Rea
Master in Creative Knitwear Design di Accademia Costume & Moda
in collaborazione con Modateca Deanna
Realizzato da Maglificio Innocenti
3
Home won’t let you stay
designed by Deeksha Bhamidipati
Master in Creative Knitwear Design di Accademia Costume & Moda
in collaborazione con Modateca Deanna
Realizzato da Studio Cataldi Group
Filati Manifattura Sesia
4
Nel profondo della Montagna
designed by Giada Song
Master in Creative Knitwear Design di Accademia Costume & Moda
in collaborazione con Modateca Deanna
Realizzato da Maglificio Loma
Filati Filpucci
Ricami di Ricami Laura
Stampe di Blu di Prussia
Tinture di Tintoria Rosta Nuova
Passamanerie di NRGY e Forza Giovane Passamani