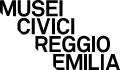Monica Gambini, architetto
Monica Gambini è nata a Reggio Emilia e dopo aver conseguito la laurea in Architettura a Firenze nel 1995, inizia il suo percorso professionale presso lo studio Mauro Severi architetto, dove approfondisce gli aspetti del restauro architettonico e dell’allestimento museale, collaborando ad alcuni progetti di allestimento museografico come il Museo Lapidario di Modena e la Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia. Si occupa, in seguito, come associata allo studio Binini Architetti & Ingegneri, di progettazione architettonica, ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici pubblici e privati. Successivamente apre il proprio studio e prende parte nel 2008 alla progettazione dell’allestimento della mostra “Matilde e il tesoro dei Canossa: tra castelli e citta’” a Palazzo Magnani di Reggio Emilia. Dal 2013 partecipa come co-fondatrice all’attività del gruppo TOO studio, in cui condivide l’attività di progettazione con l’arch. Marco Denti. TOO studio si configura come gruppo aperto e fluido, in cui convergono le diverse professionalità necessarie allo sviluppo completo ed organico dell’intero processo progettuale, con un’apertura all’introduzione dei temi dell’interazione digitale.
In relazione all’attività espositiva, nel 2016 progetta l’allestimento della mostra “Liberty in Italia”, sempre a Palazzo Magnani, e dal 2017 cura gli allestimenti a Palazzo Roverella di Rovigo: nell’ambito di questa attività si colloca la mostra “Giapponismo. Venti d’Oriente” (dal 28 settembre 2019 al 26 gennaio 2020 a Rovigo, Palazzo Roverella), per la quale il curatore Francesco Parisi ha richiesto ai Musei Civici di Reggio Emilia l’opera di Antonio Fontanesi “Ingresso di un Tempio a Tōkyō”, opera eseguita dall’Artista, a ricordo della sua esperienza giapponese, basandosi su ricordi e schizzi personali e anche su materiali eseguiti dai suoi allievi, rimasta incompiuta a causa della sua morte avvenuta nel 1882.
Abbiamo chiesto a Monica di illustrarci il percorso che ha portato alla realizzazione di questa esposizione per conoscerla direttamente dalle sue parole.
Come è nata questa mostra? Quali sono stati i passaggi che hanno portato alla sua realizzazione?
La mostra “Giapponismo. Venti d’Oriente” si inserisce nella programmazione triennale di mostre d’arte presso Palazzo Roverella a Rovigo, promosse dalla Fondazione CARIPARO in collaborazione con il Comune di Rovigo e l’Accademia dei Concordi, e prodotte da Silvana Editoriale.
L’ampio e articolato progetto curatoriale di Francesco Parisi, con la collaborazione di Rossella Menegazzo per la sezione “Giappone”, ha avuto una lunga preparazione dovuta ad una ricerca meticolosa di opere che potessero rappresentare nel contesto europeo l’influsso dell’arte giapponese.
Come si articola la mostra e quali sono i temi narrativi che sviluppa?
La mostra si articola secondo sezioni distinte per area geografica, determinando l’asse portante del percorso espositivo. Così si susseguono Francia e Belgio, Austria e Boemia-Moravia, Inghilterra, Giappone e Italia, la quale apre e chiude il percorso. In questo modo si è potuto dare evidenza a due momenti caratteristici del recepimento dei modelli orientali: Japonaiserie e Japonisme.
Nella sala di apertura della mostra, infatti, le opere scelte manifestano quel gusto pittorico che utilizza elementi giapponesi, come un ventaglio o un paravento, per connotare con un’aria esotica una costruzione pittorica pienamente accademica. E’ proprio in questa prima sezione che è stato collocato “L’ingresso al tempio” di Antonio Fontanesi, artista e direttore della scuola di Belle Arti a Tokyo, in cui lui stesso insegnava le regole e il fare artistico occidentale ad allievi nipponici, invertendo in questo caso la direzione dell’influenza artistica innestando nei soggetti classici giapponesi la rigorosa costruzione prospettica e gli effetti naturalistici del chiaroscuro. Al termine del percorso sono invece raccolti gli artisti che hanno sviluppato un linguaggio altro, caratterizzato da una personale sintesi tra oriente e accademia.
Il tema emergente dalla scelta curatoriale non è solo quello di sottolineare i differenti caratteri giapponisti nell’arte dei vari paesi europei, ma anche quello di rilevarne le assonanze, le contaminazioni stilistiche, tecniche, formali ed iconografiche derivate da un paese come il Giappone, lontanissimo sia per distanza geografica che culturale dal contesto occidentale. In mostra si trovano così accostate alcune opere giapponesi e occidentali, in modo da creare una sorta di eco artistica che rende evidente come l’apparente semplicità dell’arte orientale riesce a stemperare la complessità delle strutture compositive occidentali. Il visitatore percorrendo la mostra ritrova un rimando di forme, prospettive, gesti figurativi declinati secondo le diverse scuole pittoriche, intercalato da alcune punteggiature che evidenziano in modo diretto come il modello giapponese sia stato ripreso ed elaborato in occidente: l’”Onda” di Hokusai e “La vague” di Paul Ranson, “La casa da tè con vista sul monte Fuji” di Utagawa Hiroshige e “Paesaggio con monte Fuji” di Emil Orlik, i “grandi pesci di Utagawa Hiroshige e le ceramiche di Galileo Chini, o ancora gli “Aironi bianchi in volo” di Maruyama Okio e il paravento magnifico dello stesso Chini.
Come si realizza l’idea di mostra che descrivi, sia dal punto di vista progettuale e tecnico, sia “emotivo”?
Questa mostra accoglie 260 opere provenienti da una settantina di prestatori. Si tratta di olii, disegni, grafiche, ceramiche, arredi, libri, kakemono, paraventi, tessuti. Ognuna di queste richiede particolari attenzioni e cure espositive per garantire la loro corretta conservazione, spesso esplicitate da richieste specifiche dei prestatori riguardo le condizioni d’illuminamento, di sicurezza e termoigrometriche.
Oltre a queste prescrizioni, che devono comunque essere monitorate ciclicamente, vi sono altri condizionamenti che, nel caso di palazzo Roverella, sono dovuti alla disposizione articolata delle sale, alle pannellature esistenti di altezze diverse, all’andamento irregolare dei solai e della copertura, al posizionamento degli apparati impiantistici. Inoltre le sale sono disposte su due livelli, condizione che inevitabilmente produce una cesura lungo il percorso espositivo.
Tutto ciò si intreccia alla necessità di garantire la miglior leggibilità dell’intenzione curatoriale nella disposizione delle opere e dell’immagine complessiva dell’allestimento. Ed è proprio in questo ambito che si innesta il rapporto di fiducia e completa collaborazione tra progettista e curatore, durante il quale avviene un confronto aperto sulle possibilità di variazioni ed adattamenti del percorso nel caso in cui subentrino particolari esigenze espositive.
Tutto questo processo coinvolge anche le altre figure che partecipano alla realizzazione della mostra, di cui l’allestimento è l’esito fruibile: registrar, grafici, restauratori, allestitori, elettricisti, trasportatori, sono alcune delle professionalità con i quali il progettista architettonico ha necessità di un continuo confronto per sviluppare e risolvere tutte le diverse problematiche.
La complessità degli spazi, il numero di opere e la loro eterogeneità materica devono amalgamarsi ad un’idea di allestimento fluida e senza limiti. Come evidenziato precedentemente, si tratta di una mostra di contaminazioni e di assimilazioni, e pertanto la distinzione tra aree geografiche è necessaria per dare un orientamento spazio-temporale, ma da un punto di vista artistico i confini risultano inesistenti. Le idee si muovono liberamente, si confrontano, si modificano. Per questo non ho voluto dare una connotazione cromatica specifica alle singole sezioni, ma ho preferito creare una varietà di visione, come se fossero tanti shoji, le porte scorrevoli delle case giapponesi, che si aprono e si chiudono su scorci di paesaggio, sfruttando l’andamento irregolare dei pannelli espositivi esistenti. Da qui scaturisce la scelta di due tonalità di bianco a ricordo delle carte di riso, alternate al colore dell’inchiostro usato nello shodo, l’arte giapponese della calligrafia, al ceruleo dell’acqua e del cielo, e all’arancio evocativo del foliage.
Questa varietà cromatica ha permesso così di annullare qualsiasi limite fisico e mentale, e di caratterizzare l’atmosfera della mostra, adattando in modo flessibile le esigenze di sfondo delle opere e di integrare le altre strutture espositive realizzate appositamente per questa mostra. L’andamento irregolare dei pannelli esistenti si prestava a questo ritmo cromatico, ma evocava anche le forme dei paraventi e dei ventagli, che hanno tracciato le linee dell’espositore dei vasi e arredi di Émile Gallé, dei ventagli di Paul Signac e Félix Buhot e delle ceramiche di Henry Van de Velde e Clément Massier, struttura porosa che tramite alcune teche integrate permette un rimando iconografico e stilistico continuo tra le opere disposte nella sala.
L’eco degli elementi della casa giapponese permangono nelle pedane rialzate, utilizzate per la “messa in scena” degli arredi, come se fossero all’interno di rivisitati tokonoma e chigaidana, nicchie rialzate in cui sono collocati tradizionalmente alcuni oggetti decorativi e d’arredo.
Un altro carattere d’ispirazione è stato quello della disposizione delle pietre poste nei sentieri dei giardini giapponesi. La loro irregolarità, apparentemente casuale, si sposava con l’esigenza di creare un espositore per oggetti che necessitano di punti di visione diversificati, come vasi, libri e piatti. Così, come se fossero dei volumi estrusi dalle pietre, i singoli espositori si alzano quanto basta per una visibilità ottimale dell’opera, evitando l’eventuale monotonia di un unico espositore.
Le ispirazioni per questa mostra non sono certo mancate, ma occorreva innanzi tutto cercare di aggirare mimetismi o citazioni troppo esplicite che avrebbero potuto appesantirne l’esposizione, così da mantenere una naturalezza nella completa artificialità, assecondando il più possibile i canoni dell’estetica giapponese.
a cura di Georgia Cantoni
Responsabile comunicazione
Musei Civici di Reggio Emilia


Foto: Carlo Vannini