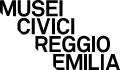2 – Il souvenir esotico, all’origine del museo
La storia del souvenir si intreccia con quella del turismo e coinvolge anche le collezioni che sono all’origine delle prime formazioni museali.
Dal Medioevo al Rinascimento, i souvenir testimoniano esperienze di viaggio delle élites: il viaggio è visto come fonte di conoscenza e come strumento di perfezionamento personale.
Se i pellegrinaggi medievali segnano l’avvio della produzione di souvenir, è dal XVIII secolo che i viaggi diventano esplorazioni sistematiche, con l’osservazione come metodo di comprensione del mondo e l’emergere del Grand Tour, percorso fondamentale nella formazione del Gentiluomo. Il Grand Tour ha le sue tappe, tra le quali l’Italia è meta privilegiata: proliferano i diari di viaggio che elencano le specialità da raccogliere in ogni luogo come souvenir d’eccellenza. I viaggiatori cercano souvenir quali dipinti, paesaggi e vedute di Venezia, Roma, Napoli, Pompei, Ercolano, statue di imperatori e figure mitologiche, arredi, gioielli e orologi da tasca. In questo panorama, Reggio Emilia si distingue per i pregiati speroni da cavallo. Molti souvenir sono prodotti su committenza, Roma fornisce una rete di produttori, artisti e artigiani, mentre artisti europei accompagnano i nobili, diffondendo gusti classici, interesse per popoli diversi, antichità romane; i souvenir archeologici vengono usati per arredare le case, preludio a un’industria e a una cultura di massa basate sull’arte antica. Un profluvio di trofei di viaggio inonda l’Europa, per confluire nelle collezioni private e nei nascenti musei di scienze, archeologia ed etnologia.
Tra la fine del XVIII e l’inizio XIX sec. i reperti del British Museum vengono classificati per favorire la ricerca accademica in campo etnologico e archeologico. A Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, lo scienziato Lazzaro Spallanzani raccoglie nel suo museo privato – che entra a far parte del patrimonio della città di Reggio Emilia alla sua morte, nel 1799 – fra i reperti naturali anche souvenir e oggetti etnografici, ricordi di viaggio. È invece con il paletnologo Gaetano Chierici, nella seconda metà dell’Ottocento, che la prima sezione etnografica del Museo di Storia Patria si forma in ausilio della nascente disciplina paletnologica e si arricchisce di materiali provenienti dai diversi continenti: con l’espansione coloniale delle potenze europee, in parallelo all’incremento delle conoscenze, si fissano quegli stereotipi culturali che danno forma alle prime narrazioni museali e che permeano ancora il nostro presente.
Approfondimenti:
Durante la cosiddetta Età delle scoperte, iniziata nel XV secolo, i velieri europei raggiunsero tutte le terre emerse del globo. Le esplorazioni diedero origine a uno scambio su vasta scala di oggetti – ma anche di cultura, tecnologia e, purtroppo, malattie – tra il Vecchio Mondo e i territori “vergini”. Da questi paesi remoti arrivavano reperti vegetali e animali (i cosiddetti naturalia) o rari manufatti (gli artificialia) che arricchivano le “camere delle meraviglie” dei regnanti e dei nobili d’Europa.
Fu però la fascinazione per l’Egitto, accesa dalla campagna napoleonica (1798–1801), a scatenare una vera e propria mania per le mummie, anche in concomitanza con la nascente disciplina dell’egittologia. Il commercio di corpi mummificati importati dall’Egitto era in verità stato costante nei secoli precedenti, dato il loro largo utilizzo in farmacopea fin dal Medioevo (si riteneva che la polvere di mummia fosse una potente panacea in grado di curare svariate afflizioni). Nell’Ottocento, però, la curiosità per i resti imbalsamati divenne un fatto di costume. Il mercato di artefatti egizi conobbe un’impennata senza precedenti, parallela all’incremento del turismo verso il Cairo – come riassunto ironicamente da Ferdinand de Géramb: «Sono convinto che, al rientro dall’Egitto, sarebbe ben poco rispettabile presentarsi in Europa senza avere in una mano un coccodrillo, e nell’altra una mummia». Nell’alta società londinese si cominciarono a tenere dei party privati (come quelli ospitati dal chirurgo Thomas Pettigrew) la cui attrazione principale era il momento dello “srotolamento”, cioè la rimozione dei bendaggi, di una mummia egizia.
Con l’avanzare della colonizzazione del globo da parte delle grandi potenze imperialiste anche i viaggi divennero relativamente più agevoli, permettendo agli esploratori e ai primi pionieri dell’etnografia di entrare in contatto con le popolazioni indigene. Il confronto con queste culture, generalmente ritenute inferiori e incivili, spesso si concretizzò in sfruttamento, schiavitù e conquista, ma alimentò anche un denso commercio di manufatti ritenuti esotici. I musei, i cui materiali provenivano originariamente dalle collezioni scientifiche e nobiliari, si arricchirono dunque di un vasto numero di reperti, tra cui figuravano anche resti umani (come ad esempio le mummie peruviane o i teschi degli antenati lavorati ritualmente nelle zone oceaniane).
Tra gli oggetti che suscitarono il maggiore interesse vi furono senz’altro le tsantsa, le “teste rimpicciolite” delle tribù Shuar e Achuar, stanziate tra Ecuador e Perù. La tecnica per fabbricare simili trofei era complessa, un procedimento delicato e meticoloso che implicava diverse bolliture e trattamenti della pelle, al termine del quale la testa si riduceva a circa un quarto delle dimensioni originali.
Per gli indigeni le tsantsa erano dei potenti talismani magici, fondamentali nelle cerimonie sacre per la prosperità del villaggio; il fulcro non era dunque l’oggetto in sé, ma la forza spirituale che poteva veicolare. Per i commercianti occidentali, al contrario, una testa rimpicciolita riassumeva in maniera perfetta l’immaginario collettivo riguardo alle “culture selvagge”. D’altronde i resoconti degli avventurieri prediligevano le tinte fosche: era una letteratura dai toni enfatici, in cui l’eroe bianco affrontava i letali pericoli delle giungle più remote, e in cui le popolazioni indigene erano sovente dipinte come brutali e animalesche; per provocare un brivido nel lettore non si esitava ad attribuire loro la tenebrosa e sempre efficace qualifica di “cannibali”. Si voleva insomma immaginare queste civiltà come “fuori dal tempo”, quasi si fossero fermate a una fase preistorica senza mai conoscere evoluzioni o trasformazioni sociali. Le tsantsa, oltre a costituire un macabro e grottesco souvenir, erano anche un simbolo della supposta barbarie di queste tribù (come se da noi non fosse tradizione mozzare teste ed esporle sulle picche o sugli spalti dei patiboli!).
La richiesta di questi manufatti crebbe esponenzialmente tanto che, ben presto, l’unico modo per un indigeno di procurarsi un fucile era scambiarlo per una testa rimpicciolita. Le compravendite divennero così frequenti che la situazione degenerò: gli Shuar cominciarono a cacciare teste per motivi non più rituali, ma esclusivamente commerciali, per soddisfare collezionisti e musei occidentali nella loro ossessiva ricerca di queste curiosità. Una tsantsa veniva scambiata con un fucile, l’arma serviva per procurarsi altre teste, barattate poi per nuove armi… il circolo vizioso si concretizzò in una strage, compiuta dagli indigeni per adattarsi ai pregiudizi degli stranieri in materia di esotismo. Come ricorda la curatrice museale Frances Larson, «quando i visitatori vengono a vedere le teste rimpicciolite […], quello che stanno veramente guardando è la storia della pistola dell’uomo bianco.»
In Nuova Zelanda si seguì un copione pressoché identico con i mokomokai, teste mozzate ai nemici durante le battaglie inter-tribali delle popolazioni Maori. A differenza delle tsantsa sudamericane, queste teste erano a tutti gli effetti dei trofei di guerra; non venivano rimpicciolite, ma conservate integralmente, essiccate ed esposte attorno all’abitazione del capo villaggio.
Se alla fine del Settecento i mokomokai erano oggetti piuttosto rari, meno di cinquant’anni dopo, in seguito ai contatti con i coloni europei, il commercio di teste in Nuova Zelanda aveva raggiunto una tale intensità che molti credevano che i Maori ne sarebbero stati completamente annientati. Anche qui si scambiavano teste per fucili, in una spirale di violenza che mise a serio rischio la popolazione indigena, in particolare durante le cosiddette Guerre del moschetto.
Oggi la sensibilità è chiaramente mutata e ormai da qualche decennio si è cominciato a ragionare molto sull’etica dell’esposizione dei resti umani; i musei che ospitano sezioni etnologiche stanno lavorando per contestualizzare questi reperti problematici e “decolonizzare” l’immaginario che per più di un secolo li ha circondati. Per quanto riguarda invece il collezionismo privato, purtroppo la situazione non è molto cambiata. Tsantsa e crani sovramodellati della Papua Nuova Guinea circolano ancora sul mercato, complici da un lato le legislazioni in materia, che variano molto da stato a stato, e dall’altro la facilità di traffici più o meno leciti consentita da internet.
Ivan Cenzi
Bizzarro Bazar
DIDASCALIE VETRINA 2
IL SOUVENIR ESOTICO, ALL’ORIGINE DEL MUSEO
1
Francesco Guardi (1712-1793), Ingresso del Canal Grande a Venezia, olio su tela
Il dipinto a olio su tela riportata su telaio di fabbricazione inglese fa presupporre il probabile acquisto da parte di un viaggiatore inglese come souvenir di Venezia all’epoca del Grand Tour in Italia
Coll. privata
2
Orologio in argento dorato con chatelaine e monogramma della Casa Reale Russa, fine Ottocento
Orologio con effige dell’Imperatrice Maria Feodorovna, dono alla sua dama d’onore Sygryda Eduardovna Amond
Coll. privata
Orologio in argento John Forrest con monogramma della Regina Vittoria, ca. 1890
Orologio dono personale della Regina Vittoria ad un diplomatico dell’Ambasciata bulgara a Londra
Coll. privata
Miniatura della Regina Vittoria in cornice d’argento e malachite
Miniatura dono personale della Regina Vittoria ad un diplomatico dell’Ambasciata bulgara a Londra
Coll. privata
Bassorilievo della B.V. della Ghiara in avorio del ‘600 con cornice coeva di legno e fregi in argento e ottone
Coll. privata
Piccolo vassoio sorrentino in olmo con intarsi
Souvenir del Grand Tour in Italia, fine del Settecento / primi dell’Ottocento
Coll. privata
Portagioie in porcellana con carillon, firma Fabergè
Coll. privata
Leone di S. Marco
Souvenir di Venezia, in marmo, con scritta sul fondo £. 10, inizi del Novecento
Coll. privata
Custodia per orologio da tasca intarsiata sorrentina
Souvenir di Sorrento con incisa la scritta “souvenir”, inizi del Novecento
Coll. privata
Custodia per orologio da tasca, fine Ottocento / primi del Novecento
Coll. privata
3
Tsantsa (testa ridotta)
America, Regione Loreto, Jivaro
Racc. Enrico Schivazappa, 1888
4
Tsantsa (testa ridotta, imitazione)
Riproduzione di testa “souvenir”, America del Sud
Riproduzione di testa “souvenir”, ricavata da una pelle di alpaca
Brasile, metà XX sec.
Coll. privata
5
Stemma imperiale brasiliano
America, Brasile
Racc. Armando e Enrico Schivazappa, 1896
Realizzato con penne di pappagallo, presenta al centro uno scudo verde coronato con ghirlanda, all’interno la Croce con l’Ordine di Cristo, una sfera armillare circondata da 19 stelle (le province). Adottato nel 1822 all’indipendenza dal Portogallo e sostituito nel 1889 all’avvento della repubblica
Fantoccio in costume da guerra
Messico e California
Racc. Luigi Bruni
Fantoccio rappresentante un guerriero. La testa è in terracotta, la capigliatura castano rossiccia, con un copricapo costituito da una doppia fascia circolare con alte penne.
Il torso e gli arti inferiori, realizzati singolarmente, sono in legno; le braccia sono mobili, in tessuto di cotone imbottito e terminano con le mani in terracotta, piuttosto abbozzate.
In pelle l’abbigliamento: la “gorgiera”, le spalline sfrangiate, la bandoliera, le maniche che coprono gli avambracci, il gonnellino che cinge i fianchi; una pelle dipinta a macchie ricopre in parte i piedi.
Sul dorso, incollata, una faretra anch’essa in legno, con colorazione maculata
Oggetti fittili con protomi femminili
America, XIX sec
Racc. Luigi Bruni
Due oggetti fittili ornati di protomi femminili. Simili come forma e decorazione, probabilmente si tratta di due falsi ottocenteschi
Testine di ceramica
America, XIX sec
Racc. Luigi Bruni
6
Statuette in legno per l’esportazione fatta in Banana
Africa, Congo, XIX sec
Racc. Cav. Giuseppe Corona
Produzione dal cosiddetto “Banana Ateliers”
7
Tre uova di struzzo
Africa, XIX sec
Uovo di struzzo, sul guscio l’iscrizione in corsivo con china “Ovo di Struzzo del Sud Africa”
Uovo di struzzo, sul guscio l’iscrizione in corsivo di colore verde “From South Africa”
Uovo di struzzo, sul guscio una iscrizione in colore rosso a caratteri gotici
8
Rostro di pesce sega con denti e con scritta «Bazar»
XIX sec.
Sull’oggetto è scritto a grandi lettere “BAZAR”, il che fa ipotizzare l’acquisto in un bazar come souvenir per viaggiatori. È presente tra i materiali provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di Parma. La mancanza di etichette precedente non consente di individuare il materiale all’interno dei documenti archivistici parmensi e quindi il nome del donatore e anno di ingresso
9
Ventagli
Giappone
Racc. Teresa Ciapparoni La Rocca
Tre ventagli di tipo uchiwa (rotondo fisso; due con immagini di bijin – “belle donne”, una, con lunga pipa, di Utamaro) e uno ogi (pieghevole, con fiori di ciliegio)
Nishiki-e
Giappone, 1950-1970
Racc. Teresa Ciapparoni La Rocca
Stampa a colori raffigurante soggetti femminili, probabilmente una scena tratta dal teatro Kabuki (teatro popolare, sorto agli inizi del XVII secolo). Già proprietà di Rosina Talamonti (1922-2001), acquistato in Giappone tra il 1950 e il 1970
Nishiki-e
Giappone, 1950-1970
Racc. Teresa Ciapparoni La Rocca
Stampa a colori raffigurante una sorta di ornitomachia (?). Già proprietà di Rosina Talamonti (1922-2001)
Daruma
Giappone
Racc. Teresa Ciapparoni La Rocca
Pupazzo portafortuna senza arti, per l’immobilità dovuta alla meditazione zen; senza occhi perché a inizio anno si esprime un desiderio disegnandone uno solo e se questo si realizza si disegna anche il secondo, altrimenti si porta il daruma al tempio shintoista per esser bruciato
Due bicchieri da sakè
Asia, Giappone, XX sec
Racc. Teresa Ciapparoni La Rocca, 2012
Usati in occasioni celebrative con l’apertura di una damigiana (uno reca scritto: “liquore giapponese di Miyagi”-“Tensho [marca], l’altro: “Hotel Capitol tokyu [una catena turistica]”
Servizio da tè
Racc. Teresa Ciapparoni La Rocca
Come d’uso, per esportazione perché con lattiera e teiera senza filtro
Aquilone
Asia, Giappone, XX sec
Racc. Teresa Ciapparoni La Rocca, 2012
10
Modello di canoa con remi e cestini
America del Sud, Terra del Fuoco
Racc. Luigi Luiggi, 1895
Modello realizzato con pezzi di scorza cuciti con filo vegetale, fondo e pareti coperti con rinforzi laterali
Cartoline postali
America del Sud, Terra del Fuoco
Racc. Vincenzo Bonini, 1958
Fotografia di indigeni della Terra del Fuoco
America del Sud, Terra del Fuoco
Racc. Luigi Luiggi, 1895
11
Zanna di tricheco istoriata
Racc. Carlo Bondavalli, 2014
Zanna di tricheco istoriata su entrambi i lati: da una parte un villaggio, con abitazioni, uomini e animali; sull’altro lato, scena di pesca
12
Piatto
Cina
Racc. Alberto e Maria Pansa, 1967
Piatto con composizione allegorica che ripropone il motivo del fagiano dal collare appollaiato su una roccia taihu presso un cespuglio di peonia in fiore; in questo caso, però, sopra questa composizione vola una grossa farfalla, simbolo di gioia e, per omofonia con “die” (nonno/nonna), simbolo di persona molto anziana
Piatto
Cina
Racc. Alberto e Maria Pansa, 1967
Piatto con decoro allegorico ispirato a una (non identificata) leggenda taoista: il più anziano dei quattro personaggi è Shou Lao, la divinità taoista dispensatrice di lunga vita, riconoscibile dalla forma del cranio e dal lungo bastone, accompagnato da un bambino e da un adulto in vesti da funzionario (probabilmente si tratta di Luxing, l’immortale/divinità taoista che elargisce ai meritevoli avanzamenti di carriera e, quindi, di livello sociale), il quale saluta rispettosamente un contadino che sopraggiunge dalla direzione opposta. La scena si svolge verosimilmente all’esterno di un tempio, di cui si riconoscono il portone d’ingresso e il colmo dei tetti.
13
Pipa kiseru
Giappone
Museo “G. Chierici” di Paletnologia, Racc. Prospero Ferretti, 1880
Pipa giapponese chiamata Kiseru. La pipa presenta il bocchino e il piccolo fornello in argento, l’asta in legno
Tsuba
Giappone
Museo “G. Chierici” di Paletnologia, Racc. Prospero Ferretti, 1880.
Due guardie (tsuba) di spada giapponese, metalliche, di forma rotonda e incise a traforo con raffigurazioni zoomorfe e fitomorfe
14
Maschera “cow mask” Djimini, Costa d’Avorio, metà. del XIX sec.
Maschera cerimoniale per danze propiziatorie del bestiame
Coll. privata